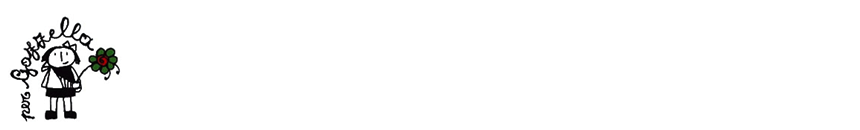Ritorno in Palestina
di Marina Rossanda
Tornando in Palestina dopo alcuni anni di assenza, nel novembre 2000, secondo mese della nuova Intifada, ero rimasta colpita dalla contraddizione tra l’evidenza della cessata occupazione nelle aree di amministrazione palestinese e il deterioramento delle condizioni di vita. Se a Ramallah era chiara la presenza di istituzioni e organizzazioni della vità civile e politica palestinese, se a Gaza erano sorti numerosi alberghi, mercati e negozi e la spiaggia era vivace e frequentata, se vi era stata un’esplosione edilizia nella striscia – non solo in città – si vedevano però anche segni di grande povertà – ad esempio mendicantibambini trascurati e mal nutriti come non era consueto vedere nemmeno nelle misere ma dignitose baracche dei campi di rifugiati. Alcuni di questi avevano cambiato aspetto, la famosa barriera di rete metallica di Deheishe era caduta – altre però erano rimaste dove i campi, ancora all inizio della loro trasformazione in villaggi, rasentavano la rete stradale israeliana cresciuta a dismisura insieme alle colonie in espansione. Ma specialmente ero impressionata dalla progressiva distruzione del territorio nelle zone dì contatto tra le aree palestinesi e le colonie, quelle di Gaza che ormai non ci dovrebbero più essere in base a tutti gli accordi, e le altre, come quelle illegalmente annesse nei dintorni di Gerusalemme: Gilo è il tipico esempio. Anche verso Ramallah, tutt’intorno a Qalandya e ad Al-Ram, c’erano montagne e solchi di terra rossa e sassi, tra i quali arrancavano in modo precario le macchine private e i taxi collettivi cercando di aggirare le infinite code al posto di blocco, che è anche scenario di tragedie quotidiane.Nablus e Jenin erano praticamente inaccessibili, per Gaza c’era un filtro come nemmeno durante l’occupazione, e a Hebron la desertificazione colpiva strade ed aree ridotte a terra di nessuno intorno alle zone palestinesi; le zone a controllo misto erano praticamente occupate, con coprifuoco lunghissimi o di durata arbitraria. Le vie di comunicazione per i palestinesi erano chiuse o trasformate in percorsi a ostacoli.Era palpabile la quotidiana minaccia, che, a ritmi imprevedibili, negava ai bambini la scuola e ai malati la possibilità di curarsi, a tutti l’elementare diritto di camminare sicuri in strada, o anche di rispondere altelefono nella propria casa se la stanza col telefono era esposta al tiro dei cannoni israeliani.Descrivendo queste impressioni per la Rivista del Manifesto (n.13 del gennaio 2001) terminavo con l’evidenza dell’esasperazione palestinese, al limite dello scontro ancora più sanguinoso, ancora in parte controllato, ma, concludevo, ‘domani chissà”. Il domani è noto: nell’agosto 2001 vidi aumentate la precarietà, le reciproche uccisioni, le azioni militari da una parte; dall’altra si facevano più frequenti gli attacchi suicidi e le imboscate. Da Israele e dalle colonie partivano raid che si lasciavano alle spalle morti e feriti, anche civili e bambini, macerie di case bombardate o spianate al bulldozer, campi e uliveti distrutti. L’aggressione, in risposta alla povera ma tenace rivolta palestinese, giungeva con missili portati da elicotteri ed aerei al centro delle zone ‘autonome”, la periferia era soggetta a incursioni e mitragliamento dai mezzi blindati. Le uccisioni mirate da parte di commandos, vere ‘esecuzioni extragiudiziali”, erano sempre più frequenti. E si sapeva degli arresti e delle condanne da parte palestinese di sospetti collaborazionisti. Tutto ciò a sussulti, diluiti in una vita quotidiana solo apparentemente normale.
Primi giorni. Con Sancia Gaetani arrivammo un giovedì; errore, dopo i primi contatti, dovemmo aspettare i tre giorni del lungo week-end imposto a Gerusalemme dalle tre religioni, per stabilire il programma delle visite a Hebron e Gaza; anche perché i nostri telefoni cellulari sembravano riflettere l’imprevedibilità della situazione, e ci sentivamo isolate. Ramallah, prima meta, non era consigliabile il venerdì (specie il primo venerdì dopo la strage di Nablus>, allora decidemmo di guardare le moschee di Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. Arrivammo dalle partì dell’ospedale Augusta Victoria in un tassi preso al volo dalle parti dell’Hotel King David, dove abitavamo nella casa vuota di un professore israeliano amico (nostro e dei palestinesi); il tassista israeliano ci prese perché il lavoro era poco, ma cercò di spaventarci, mostrando l’imponente schieramento di polizia tutt’intorno alla zona delle moschee. In verità era tranquillizzante il rigido divieto di accesso per tutti anche al Muro del pianto e al cimitero ebraico ricostituito dopo l’occupazione alle falde del Monte degli Ulivi. Il tassista ci aveva detto, più scuro che trionfante: o Israele riesce a diventare la potenza dominante in Medio Oriente o ci sarà un enorme spargimento di sangue. All’ospedale Augusta Victoria cercò di convincerci a rifugiarci là. Ci facemmo invece lasciare alla grande chiesa cristiana, peraltro brevemente aperta solo per noi, e poi ci dirigemmo verso il villaggio palestinese sulla cresta , tutto chiuso, negozi, bar e albergo, e oltre, fino all’ex hotel Seven Arches con la sua terrazza panoramica. Il cammello bardato in servizio turistico, vecchia conoscenza, si riposava seduto. Saremo stati una dozzina tra uomini palestinesi e gente in visita, divisi tra coloro che cuocevano felicemente al sole ardente del mezzogiorno d’agosto e quelli che si accucciavano, come me, nel cono d’ombra degli alberelli. Nel silenzio totale si levava dalla moschea al–Aqsa la preghiera musulmana. Lo spiazzo delle moschee era vuoto , come la valle del Kidron che da quello ci divideva. Vuoto e silenzio, vibranti della voce amplificata del celebrante, nella quale percepivo toni drammatici, divennero sempre più tesi per tre quarti d’ora, fino alla fine della cerimonia; poi la folla degli ammessi, solo anziani, solo residenti a Gerusalemme ,usci per un percorso inconsueto sotto la vigilanza della polizia israeliana, che comunque non tralasciò di arrestare, come apprendemmo poi, alcuni sanitari volontari, in attesa in caso di guai. Sulla terrazza comparvero macchine e venditori di immagini della città e noi fummo catturate da un tassista arabo.Il resto del week-end fu dedicato al suk della città vecchia, a vedere un’amica cooperante e un’altra serie di amici convergentì al ristorante arabo in voga. Vi fu solo una breve scappata a el–Bireh, per acquisti di ricami e un postumo omaggio a Samiha Khaleel nella sua Fondazione Tn’ash el usra , poi la visita a due amiche nei loro uffici di organizzazioni di donne situati esattamente al posto di blocco di al-Ram, sonnecchiante nel sole; a piedi lo scavalcammo di lato senza problemi.Riuscimmo anche a vedere il Console generale e il direttore della cooperazione italiana, che si dimostrarono molto cortesi; ne scaturi qualche ipotesi interessante di collaborazione con una università e l’apertura verso nuovi progetti.Il lunedì rientrò Marisa Musu con Agnese Manca ed Edoardo, nuova recluta della campagna per Gazzella, reduci da un giro per Gaza per le seconde consegne e le visite alle famiglie dei piccoli feriti gazanì adottati. Erano ormai 120. La squadra era stanchissima ma contenta e la cena al Jerusalem Hotel fu piacevole. L’indomani cominciava il nostro turno.
Verso Hebron. Prelevate dall’amico fisioterapista Jamal che lavora all’UNRWA, con un veicolo marcato ONU, partimmo presto, e finimmo per stare in giro fino a buio. Ci sono nove posti di blocco sul percorso della strada principale, ma ne evitammo una buona parte grazie all’esperienza di Jamal, gli altri furono passati o aggirati. Vicino a Betlemme visitammo brevemente il nuovissimo municipio di Tuku’a, una delle 35 aree che fanno capo al distretto di Betlemme dal 1997, prova di avviamento del decentramento amministrativo nelle zone palestinesi autonome. Il presidente, peraltro non eletto, ma nominato dall’ANP tra le persone stimate localmente, ci disse che Tuku’a è un nome antico, e l’area conteneva un sito archeologico, già oggetto di visite turistiche e di un programma di ricerca; ce ne aveva parlato la nostra amica che lavora con un archeologo palestinese a Gerico quando la lasciano entrare. Una fetta di terra di 10000 dunuim (circa mille ettari) era stata però presa dai coloni dell’omonimo insediamento ebraico di Tekoa, che oltre a prendersi la zona archeologica non cessavano di effettuare provocazionì, sequestrando anche parti del raccolto di olive e uva.La strada, dalle parti di Beit Jalla costeggiava un valloncello dove erano stati uccisi due militanti palestinesi con un missile lanciato da un elicottero israeliano. Per un percorso tortuoso che non potrei ricostruire arrivammo poi a Saeir, grosso villaggio del distretto di Hebron, con un centro antico, una moschea nuova ,costruzioni in corso ; qui abita la Gazzella titolare della nostra campagna di adozioni. Il villaggio è anche fiero di ospitare un centro di conservazione e mostra della civiltà contadina tradizionale, ‘El Sanabel” (Le spighe), che pubblica una rivista con numeri tematici.
Gazzella. Trovare la casa di Ghazalah Jaradat, questo èil nome della nostra prima adottata, non fu del tutto facile; i Jaradat sono moltissimi a Saeìr. I nostri abitano con altri della famiglia in tre casette –semplici parallepipedi a un solo piano – in cima a una ripida collinetta spelacchiata, tutta sassi. Ci accolsero con la solita cordialità. Attesi di vedere Ghazalah con ansia, negli occhi il ricordo vecchio quasi 10 mesi, di una creatura magra a testa rasa, che si dimenava ancor priva di coscienza nel letto dell’Ospedale Al-Ahli; era stata operata al cervello una ventina di giorni prima, con prontezza e bravura, per estrarre la pallottola e decomprimere il cervello gonfio (la prima diagnosi al pronto soccorso era stata di ‘morte cerebrale”). Avevo sempre sperato che si riprendesse, ho esperienza di traumi cranici e so che i ragazzini fanno grandi recuperi, ma nel salottino nel quale intanto venivano imbanditi enormi piatti di frutta, mentre Ghazalah tardava a comparire, la mia paura per lei cresceva. Finalmente comparve una irriconoscibile fanciulla bruna, bella e ben messa in un vestitino a pantaloni verde chiaro, mi parve un po’ incerta ancora nel movimento e nel linguaggio. Ma era tutta timidezza. Apprendemmo che era già stata precocemente rioperata per riposizionare in testa il pezzo di scatola cranica saggiamente allontanato per alleviare la pressione sul cervello gonfio. Mi mostrarono la pallottola rotonda metallica, ricoperta di una sostanza molliccia, il residuo della plastica dopo l’impatto ad alta velocità col cranio. Il lembo osseo era stato conservato e riusato – era la prima volta che lo facevano in quell’ospedale. Poi la ragazza era stata riabilitata localmente e in Iraq, dove appresi esistere un centro di recupero dì alto livello (in effetti la riabilitazione richiede un minimo di tecnologia, e molta capacità personale dei curanti, e può non essere stata influenzata dall’embargo). Dopo, era tornata a scuola, superando l’esame dell’ottavo livello. Mentre scattavo fotografie e discorrevo con i parenti, un padre (agricoltore), bell’uomo fiero, una madre dal volto precocemente segnato, zie o cugine giovani e sorridenti, lo zio singolarmente giovane, innumerevoli ragazzini, inclusa purtroppo una cuginetta resa cieca da un trauma, muta e triste, Ghazalah si sciolse e cominciò a sorridere. Ha una sorella e quattro fratelli. Parlava un inglese notevolmente corretto; raccontò le circostanze del suo ferimento–uscita di scuola in mezzo ad alcuni compagni stava avviandosi a casa. Non nascose il suo sentimento: “loro ci odiano e noi odiamo loro”. Vuoi fare prediche a una che hanno quasi ucciso a 14 anni? Ma Ghazalah non èuna dura; non ha ancora deciso che cosa fare da grande– ‘forse l’infermiera o il medico per aiutare gli altri come hanno aiutato me” e poi quando cerco di farle dire se ha un desiderio, di un regalo che possa farle per le feste , dopo qualche esitazione, dice dì far io la scelta, ma poi, a bassa voce, “un regalo mi piacerebbe molto, un pezzetto dì pace”. Oh Ghazalah quanto vorrei potertelo fare, questo regalo. Qualche altra foto, ora che il sorriso la rendeva luminosa – sembrava contenta di sé – e poi dovemmo congedarci, deludendo la famiglia che ci voleva a pranzo. Solo vedemmo il terzo ragazzo colpito da disgrazia in questo gruppo familiare, un tredicenne con gravi postumi fisici e psichici di un incidente d’auto. Nell’andare, decidemmo con Jamal che qualcosa andava fatto per i due più sventurati cugini di Ghazalah, e ne sta nascendo un progetto di sostegno ad attività riabilitative, specialmente per ciechi – ma anche per altri gravi casi che la struttura sanitariapalestinese, sovraccaricata dai feriti dell’intifada, non regge.Una base c‘e’ già; la ‘Hebron branch” della ‘Palestine Disables General Union” è molto attiva; incontrammo alcuni membri del direttivo, tra cui il presidente, non vedente, Ibrahim, nell’edificio di nuova costruzione donato dall’tJNDP con altri contributi locali, posto in una vasta area della zona palestinese autonoma tutta dedicata a funzioni didattiche e affini. Nell’edificio si stava svolgendo un campo di ragazzi, insieme disabili e normali, della durata di 15 giorni per ogni turno. Già in passato 180 ragazzi hanno frequentato questi campi, che sono stati un successo sia per aiutare i disabili, sia per lenire le infinite cause di disagio del quale soffrono ora i ragazzi palestinesi tra occupazione, povertà diffusa, paure di attacchi, scolarità irregolare, spettacolo continuo di morte e violenza. Di questa struttura non ancora completata, vedemmo un inizio di biblioteca, una sala con alcuni computer, un salone per giochi sportivi, una sala per disegni e altri giochi didattici, un vasto spazio all’aperto, con un embrione di giardino. L’Associazione dovrebbe esser un buon riferimento per un programma di supporto ai non vedenti con le nuove tecnologie disponibili.
A Dura, altra cittadina del distretto di Hebron facemmo visita alla famiglia di Jamal, la nostra guida.Il padre, agricoltore, vestito all’occidentale, mi ricordava i pionieri emiliani dell’imprenditoriacooperativa, in effetti era stato proprietario di terre abbastanza vaste, le più fertili in pianura, coltivate a ulivo, frutteti e vigneto; queste se andarono nel nuovo stato d’Israele nel 1948. Restò loro ancora della terra, tutta sassi; si tirarono su le maniche, tolsero le pietre, ripiantarono tutto e ricominciarono da capo. Da soli era difficile, formarono allora un gruppo per ottenere dall’ l’ANERA (scoprimmo così un amico comune, Ibrahim Matar) un prestito da restituire in tre anni. Ma già l’anno seguente erano in grado di restituire il prestito e insistettero per farlo, diventando così modello per altri gruppi di cooperazione. Nel 67 furono occupati di nuovo, ma ora sì trovavano in una condizione abbastanza fortunata. Quest’area della zona autonoma è lontana da insediamenti israeliani e quindi poco soggetta ad attriti. La famiglia cresce, tutti lavorano o sulle proprie terre o fuori,sono autosufficienti. Anche il nostro Jamal si stava costruendo per la vecchiaia un piano sopra l’abitazione dei suoi.Prima dì rientrare passammo per la sede del TIPH, il gruppo di osservatori italiani, scandinavi e francesi che dovrebbero garantire la convivenza senza incidenti tra coloni ebrei e palestinesi. Ma ci confermarono che non avendo poteri d’intervento, non riescono a prevenire molti incidenti gravi che possono solo essere registrati e riferiti(non è ben chiaro a chi); e la loro attitudine benchè gentile era tra il frustrato e il disincantato. Tornando a Gerusalemme a buio, il traffico era scarso e per qualche motivo l’attenzione ai posti di blocco molto vaga, salvo qualche breve polemica.
Gaza. L’indomani andammo a Gaza, in tassi fino al confine di Eretz, poi dopo qualche rituale burocratico, questa volta senza intoppi grazie anche alla presentazione del console, traversammo la terra di nessuno, al di là della quale ci aspettava il mezzo degli amici del ‘Medical Relief”. Ci avviammo subito verso il villaggio dove vive il ragazzo ‘adottato” da Sancia , cieco per uno sparo che gli ha leso l’incrocio tra i nervi ottici. Era un quindicenne vivace, capo del suo gruppetto nelle sassaiole, bravo a scuola. La cecità lo ha colpito duramente, ancora non aveva accettato la realtà. Sancia annotò dati e raccolse documenti per verificare che nell’ospedale dove è stato trattato abbiano effettivamente esaurito ogni possibilità; contava di impegnarsi a procurargli strumentazione che possa aiutarlo a continuare efficacemente gli studi.Dal villaggio proseguimmo per il centro-sud della Striscia, dove si vedeva la devastazione delle zone prossime agli insediamenti israeliani, Netzarìm, un altro nome che non ho fissato: campi bruciacchiati dove li ricordavo verdi, o terra nuda dove ricordavo palmeti– era il punto di innesto della nostra strada su quella centrale della striscia, controllata dai soldati israeliani; più a sud i segni diretti dei bombardamenti su Khan Yunis. Qui erano sorti molti caseggiatì per ospitare rifugiati, ma vari di questi, noi ne abbiamo visto due gruppi, sono stati cannoneggiatì al punto di diventare inabitabili. Uno di questi isolati, che una striscia di terra nuda e macerie separava da un lungo muro che nascondeva in parte la colonia con l’edificio a forma di stella di Davide e altre strutture, era affiancato da numerose tende per i nuovi rifugiati. Era uno spettacolo da guerra pesante. La rabbia e la tristezza non mi facevano sentire l’afa, che mi avrebbe ridotto uno straccio nel pomeriggio, dopo un pranzo e un tentativo di visita al mercato tradizionale, fittissimo di banchi, con vestiario non locale, a buon mercato. Sancia, più robusta, avrebbe accompagnato Naima del Medical relief , bella ragazza purtroppo disabile, al suo villaggio mentre mi buttavo a riposare; la sera mangiammo fichi e uva dopo avere ricuperato candele per ovviare al solito blackout, gentilmente offerto pressochè tutte le sere dall’azienda israeliana di elettricità. La notte era caldissima, forse perché la foresteria che ci ospitava non era verso mare, come gli altri posti dove usavo dormire negli anni passati. Ero un po’ disorientata, non riconoscendo quasi nulla, solo la grande via Omar el Mukhtar e alcune sue trasversali. D’altronde le nuove costruzioni sono molte a Gaza Città, c’è un viale a giardino ben tenuto, grandi edifici. Non c’era tempo per altri giri, dovendo vedere sia Abu Akram del Medical Relief, sia un’altra nostra più vecchia conoscenza, il farmacista Abu Hasan, segretario di Haider Abdel Shaf i, la mattina seguente, e dovendo partire presto per non mancare il nostro appuntamento col tassi a Eretz, e poi quello a Gerusalemme col Direttore della cooperazione italiana. L’incontro successivo con rettore e docenti dell’Università di al Quds, che aveva da poco aperto la prima facoltà di medicina dei Territori Occupati, sarebbe stato interessante per le ipotesi di collaborazione che in quest’autunno ci proponevamo di costruire. Intervenne ancora l’attentato sanguinoso alla Pizzeria Sbarro, 1’ occupazione dell’Orient House per rappresaglia, della quale vedemmo le prime proteste. Poi partimmo.E’chiaro che nelle settimane estive tra la nostra partenza, l’li agosto, e questa fine di settembre, la situazione si è prima aggravata a Gerusalemme per attentati , scontri, ripetute invasioni israeliane di aree palestinesi, e la persistente chiusura della Orient House. Poi gli attacchi a New York e Washington e le conseguenti reazioni, con annunci di guerra e clima estremamente teso, hanno reso il discorso qui più difficile. A meno che la pressione USA – tanto attesa in passato – e l’apparente nuovo impegno dell’Europa non producano, non certo la fine dell’intifada che sarebbe una sconfitta, ma un clima meno esasperato nel quale i palestinesi possano cominciare a porre le questioni reali della fine dell’occupazione coloniale e militare, e di un loro vero stato. Ancora una volta non c’è che da aspettare un lungo domani.