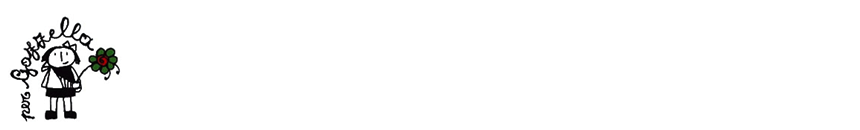Viaggio a Gaza
Arrivati all’aeroporto di Tel Aviv, ai due lati del percorso di uscita dove si attende l’arrivo dei passeggeri, si vedono come due grandi corsi d’acqua incanalati in vasche rettangolari, disseminate da fontanelle zampillanti. Più che una sensazione di fresco avverto come un pugno nello stomaco pensando al popolo palestinese derubato delle sue risorse idriche. Il 2 agosto, dopo una sosta a Gerusalemme in attesa di un’autorizzazione per entrare a Gaza, in tre: Marisa, Edoardo ed io del Progetto “Gazzella”, prendiamo un taxi (targa gialla), di quelli circolanti in Israele e a Gerusalemme, e in un’ora e mezza circa arriviamo ad Erez, confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Superato il controllo dell’Autorità israeliana, a 500 metri di distanza, troviamo quello dell’Autorità palestinese che dopo aver controllato i nostri passaporti ci da il “benvenuto” e ci offre un bicchiere d’acqua fresca. Prendiamo un secondo taxi (targa verde stavolta), per Gaza e Territori occupati con l’esclusione di Gerusalemme Est, arbitrariamente annessa da Israele entro i suoi confini , dopo la guerra del 1967. In poco più di un quarto d’ora siamo in Gaza città (400.000 abitanti), dove ha sede il Medical Relief Committees di cui siamo ospiti. Con due dei loro pulmini, ci accompagnano presso le 120 famiglie dei bambini feriti, già assegnati in affidamento a distanza ad altrettante famiglie italiane, aderenti al Progetto “Gazzella”. Inizia così una tre giorni d’intenso lavoro per i campi di Jabalya, Khan Yunis, Rafah e loro frazioni, attenendoci anche noi al regime di un solo pasto al giorno, come la popolazione locale è da tempo costrette a fare. Percorriamo da Nord a Sud l’intera Striscia di Gaza (1.500.000 abitanti) per raggiungere le numerose casupole sparse in zone più o meno desertiche e lungo le linee di confine tracciate dall’Autorità israeliana, dove gli scontri tra popolazione ed esercito occupante sono quasi quotidiani.
Il 1° giorno andiamo a Jabalia , a Nord di Gaza. L’autoradio sempre accesa, con notizie e canti malinconici in lingua araba, ci accompagna lungo la strada asfaltata, spesso costeggiata da cumuli di sabbia, traccia palese degli alberi sradicati dagli occupanti. A tratti incontriamo baracche intercalate da imponenti costruzioni e macchine che si alternano con carrette trainate da asini. A Jabalya veniamo accolti, oltre che dal personale di zona del Medical Relief, anche da una folla di bambini scorrazzanti per le strade polverose sulle cui mura campeggiano le immagini dipinte dei loro compagni martiri. AJabalya, come a Bait Lahia e a Bait Hanun, andiamo a trovare nelle proprie case i bambini feriti. Due di noi con l’autista e l’interprete ed io accompagnata dal Direttore del C.B.R “Community Based Rehabilitation” che descrive il territorio di Jabalya come segue: 100.000 abitanti di cui 1400 disabili, un solo club per la gioventù, dove i ragazzi si incontrano, si raccontano e solidarizzano fra loro sostenendosi l’un l’altro nella difficile condizione di vita loro imposta dall’occupante israeliano. La gente vive di espedienti, il 70% della forza lavoro, prima impiegata da Israele è da 8 mesi ormai disoccupata essendo stata sostituita da operai Rumeni. Nuha, l’assistente sociale che cura il Programma di Riabilitazione dei giovani nel campo di Beit Hanun (27.000 abitanti), zona agricola, sottolinea come la famiglia numerosa sia funzionale a questo tipo di economia, bisognosa di braccia per lavorare la terra. Si sofferma poi su alcuni problemi come, i matrimoni celebrati in età molto giovane e tra parenti, la donna non percepita dall’uomo nel suo giusto valore e perciò discriminata. E’a lei, che consegniamo ogni volta la busta con il contributo della famiglia italiana, per i bisogni più immediati del ragazzo ferito e della famiglia. L’accoglienza è semplice, ma cordiale e man mano che ci addentriamo nei motivi della nostra visita ci parlano della loro solitudine, dei sacrifici da affrontare per arrivare a sopravvivere alle restrizioni imposte da Israele e, in fine, della necessità di far conoscere al mondo la realtà in cui vivono perché non siano lasciati soli.
Il 2° giorno andiamo a Khan Yunis, cittadina fondata dai Turchi dei quali rimane ancora una fortezza. La sua popolazione si è quasi raddoppiata in 13 anni, passando da 70 a 120.000 abitanti. Prima di entrare in città, ci fermiamo al crocevia di Abu Kuli in attesa che i soldati israeliani ci permettano di proseguire. Dalla loro torre di osservazione, azionano il semaforo verde o rosso a loro discrezione senza essere visti, pronti a sparare, afferma il nostro autista, su chiunque osi scendere dalla macchina. A conferma di questo c’è il vicino “Crocevia dei Martiri” con poche case palestinesi, tra blocchi di cemento e montagne di sabbia. Khan Yunis si trova a Sud della Striscia di Gaza, vicino alla costa del Mediterraneo. Il punto di confine verso il mare, tracciato da Israele, è denominato Hajz At-Tuffah. E’ qui che la maggior parte dei bambini di Khan Yunis, Bani Suhaila, Khaza’ah, Na’ymah e Ma’an, sono stati feriti per lo più alla testa e al petto, ma anche alle mani, all’addome, al pelvi e alle gambe. Tutt’intorno palazzi ridotti allo scheletro e cumuli di macerie, mentre i bambini giocano davanti alle tende piantate nello spazio lasciato dalle case distrutte. Ad ogni lancio di missile dei soldati israeliani, appostati a poche centinaia di metri, e ad ogni funerale di un loro martire, i bambini manifestano sfidando il divieto dell’occupante del quale diventano facile bersaglio. Quella presenza armata, minacciosa per la popolazione locale, è lì a protezione di alcune famiglie ebree insediatesi lungo il litorale. A poca distanza, vediamo immagini dipinte sui muri di ragazzi uccisi da Israele su quel confine creato ad arte per rendere la vita impossibile a chi vi abita. Attorno ai giovani martiri, bandiere palestinesi dipinte a tinte forti e le solite scritte coreografiche in lingua araba: “Palestina libera con Gerusalemme capitale! Intifada fino alla vittoria !”. Ismail, che mi fa d’autista e d’accompagnatore, parla con passione del suo lavoro in collaborazione coi Medici senza Frontiere (greci e francesi) nel Programma di Riabilitazione dei giovani. Sottolinea la difficoltà nell’assistenza soprattutto a quelle famiglie che vivono nella striscia di terra tra le postazioni militari e le case dei coloni. Striscia che nel piano di Oslo doveva far parte d’Israele per cui resta completamente isolata. L’autorizzazione al personale del Medical Relief di raggiungere quelle famiglie è discrezionale e spesso viene loro negata dai militari israeliani, anche in caso d’urgenza. Dal lato opposto, verso il confine israeliano, c’è il campo di Bani Suhaila, la cui popolazione lamenta la completa dipendenza, per tutti i beni di prima necessità: farina, zucchero ecc., da Israele che impone il divieto assoluto d’importazione da altri paesi. Si ricollega alla difficile situazione in cui vive la gente anche la tragedia tra famiglie di 2 giorni fa: l’omicida di un collaborazionista, tornato in libertà dopo un periodo di carcere, viene ucciso dai parenti della vittima. Lo scontro tra le due famiglie è risultato in 8 morti, 4 per parte. L’ estrema povertà in cui vive la popolazione, dice Ismail, spesso col solo sussidio dell’UNRWA in quanto rifugiati, porta i genitori a far sposare i figli giovanissimi. Il sussidio per ogni figlio cessa al compimento dei 17 anni, i genitori non riuscendo più a tenerli a loro carico li spingono a farsi una famiglia per conto proprio. Raggiunta l’età adulta, l’uomo specialmente trova normale sposare una seconda moglie da affiancare alla prima, quando questa non viene abbandonata insieme ai figli. Accanto a questo problema c’è quello del gran numero di disabili, spesso discriminati e non bene accetti dai cosiddetti “normali”. Il nostro lavoro, dice Ismail , è quello di sensibilizzare le persone al rispetto e all’accoglienza, specie di chi è meno fortunato, la cui vita ha lo stesso valore di quella degli altri.Ripercorrendo la via del mare, ci fermiamo a Der Al Balàh “Casa dei Datteri”, villaggio agricolo i cui abitanti, beduini come ilnostroSalim, di natura mite e tenace, conoscono il ripetuto sradicamento delle palme da datteri da parte dei bulldozers israeliani. Quelle palme, che conferiscono il nome al villaggio, insieme a piccoli greggi di pecore costituiscono la fonte principale di sussistenza. Vediamo vaste distese di terra rimossa con residui di alberi sradicati a protezione, dice Israele, dei coloni ebrei impiantatisi in quel lembo di terra fertile, lungo le coste del Mediterraneo. Le palme sradicate, osserva Salim, vengono spesso ripiantate dagli ebrei in altre zone della Striscia di Gaza per affermare che quella è tutta terra loro.
Il 3° giorno partiamo alla volta di Rafah, nella parte più a sud della striscia di Gaza, ai confini con l’Egitto. E’ uno dei punti più caldi, con case distrutte, strade chiuse da pile di grossi contenitori riempiti di sabbia e cemento. Il punto di ritrovo dei bambini che reagiscono alla violenza armata dei soldati israeliani lanciando pietre, si chiama Abuab Salah Ed-Dini “Le porte del Saladino”. Traccia il confine tra Palestina ed Egitto, un muro eretto con blocchi di cemento e pali di ferro, dietro cui vi sono appostati i soldati israeliani pronti a sparare all’avvicinarsi di chiunque, anche dei bambini che si divertono sostituendo la bandiera israeliana con quella palestinese. Quei bambini, che ora giocano fra le rovine delle case distrutte, vedendoci accanto a quel muro ci raccontano di due donne egiziane uccise dai soldati israeliani, per avere osato inoltrarsi troppo. Il campo di Rafah, forse più di ogni altro, sembra sintetizzare l’attuale situazione di precarietà e disagio comune all’intera Palestina occupata. La popolazione è esposta quasi in permanenza al lancio di missili dei soldati israeliani ed alle incursioni notturne di elicotteri e carri armati. Appena rientrati in sede apprendiamo, infatti, che l’esercito occupante ha ucciso a Rafah un altro palestinese. Al ritorno ci fermiamo sul lungomare della città di Gaza. E’ l’ora del tramonto, i bambini non intendono uscire da quelle acque chiare e tiepide del Mediterraneo. In spiaggia, sedute attorno ad un tavolo come al bar, gruppi di donne e famiglie con seggiolini e accanto il Narghilè, bandiere palestinesi sventolanti su una barchetta in riva al mare e giovanotti che si divertono ad esibire i loro muscoli. Il tutto, rallegrato da aquiloni fatti con sacchetti di plastica bianca e celeste, che trascinati dai bambini in spiaggia, solcano il cielo con la stessa maestosità di quelli ben più sofisticati che volano nei nostri cieli. La città di Gaza si costruisce giorno dopo giorno. I grattacieli si alternano ai palazzi, il giardino sulla via Omar al Mukhtar col monumento al Milite Ignoto e la sede del Parlamento Palestinese, trasmettono un senso normalità, così come la piazza con la fontana luminosa attorno alla quale giocano i bambini. Non lontano scorgiamo un cimitero con accanto la prigione nella quale l’Autorità Palestinese aveva rinchiuso molti membri di Hamas, uccisi poi da Israele bombardandone l’edificio su pretesto di non credere alla versione ufficiale del PNA. Arafat indignato, afferma Salim, per la sua incapacità di proteggere i membri di Hamas in carcere, li lascia tutti liberi, suscitando così l’ira del governo israeliano. Nelle strade, nei suq, nei grattacieli, così come nei baraccati, si vedono i segni dell’occupazione. Israele distrugge con le sue incursioni armate da terra, mare e cielo e i palestinesi ricostruiscono. Tanti edifici restano, tuttavia, incompiuti non solo per mancanza di fondi, ma anche per paura che vengano di nuovo rasi al suolo da Israele. Questo stato di precarietà unito a complicazioni burocratiche scoraggia i palestinesi residenti all’estero di investire nella propria terra. Fiero di essere un beduino, il nostro autista mantiene sempre il morale alto, pur definendo Gaza “la più grande prigione del mondo, assediata da ogni parte e costantemente sotto tiro”. Aiman, giovane volontario, traduttore Arabo-Inglese, ex studente all’Università di Bir Zeid oggi disoccupato, afferma: “Noi Palestinesi, votati alla causa del nostro popolo, dopo aver dato tutto ciò che abbiamo, dobbiamo dare anche l’anima per riavere indietro la terra, la casa, la patria”
.Cosa sognano i bambini: La quasi totalità dei bambini di notte sogna di essere inseguiti dai soldati israeliani, di sentirsi sparare addosso e di lanciare pietre contro carri armati. Agli incubi notturni fanno riscontro i loro sogni ad occhi aperti: poter vivere in pace e giocare in libertà come tutti gli altri bambini, riavere la loro casa e la loro terra, liberare la Palestina e riconquistare Gerusalemme. Per questo ci chiedono di star loro vicini in questa lotta. Da grande c’è chi vuol fare il medico per curare tutti i bambini feriti e chi vuol diventare un ingegnere per ricostruire la sua casa e il suo paese. C’è anche chi vuole arruolarsi nelle file dei combattenti per sconfiggere il nemico e riportare la pace in Palestina. Le madri: Spesso accusate dalla stampa occidentale di mandare i loro figli a morire rispondono: “Nessuna madre al mondo manda i propri figli a morire”, “I nostri figli soffrono per le ferite riportate, la casa distrutta, la mancanza di libertà, l’uccisione di un parente o di un amico da parte dei soldati israeliani e reagiscono a questo manifestando contro questa presenza armata in mezzo a noi”, “Noi non mandiamo i nostri figli a lanciare pietre, ma diciamo loro che vogliamo vivere in pace come gli altri popoli e che questo richiede sacrifici”, “Dio ci ha dato i figli ed Egli se li riprende quando e come vuole”. Fra le testimonianze sentite c’è anche quella di una madre che si dichiara pronta a sacrificare i suoi 9 figli e se stessa per riavere giustizia, dignità e pace.
Da Gerusalemme a Ramallah: A conclusione di questo viaggio, una giornata vissuta a Ramallah, a 10 km. da Gerusalemme. Il tempo per arrivarci non è sempre di pochi minuti, può anche essere di ore, come oggi. Nei pressi di Kalandia, aeroporto palestinese di Gerusalemme, attualmente sotto controllo israeliano, ci viene chiesto di scendere dal taxi e seguire la lunga fila di persone e di macchine, in cammino verso Ramallah. Scortati dalla polizia percorriamo la strada, costeggiata da blocchi di cemento, sotto un sole cocente. Dall’altro lato, in direzione opposta, vi è un’altra fila di macchine, furgoncini e camion diretti a Gerusalemme col loro rispettivo carico di persone, di prodotti per rifornire i negozi e di animali forse destinati al macello. Attira la mia attenzione un camion a cielo aperto, con un grosso carico di polli, immobili e come accecati dal sole, quasi agonizzanti, colpevoli anch’essi di essere “polli palestinesi”. Terminata la lunga marcia siamo costretti a prendere un secondo taxi e ripagare la corsa. Anche così si può contribuire ad accrescere le entrate dello stato israeliano e comunque a stremare la popolazione palestinese. Giunta a destinazione, un’amica m’invita alla cerimonia di elogio funebre di Faisal Husseini. Israele aveva negato il permesso ai palestinesi dei Territori occupati di entrare a Gerusalemme per il funerale del loro Leader. I permessi negati diventano ancora più gravi quando colpiscono la famiglia. E’ il caso di molti giovani trasferitisi dalla Striscia di Gaza a Ramallah o ad altra città “autonoma”per motivi di lavoro, incluso l’arruolamento in Polizia. Per molti giovani, il servizio militare rappresenta una possibilità di impiego, ma una volta feriti e non più in grado di svolgere il loro compito, Israele li costringe a vivere lontani dalle famiglie e spesso in condizioni disagiate impedendo loro di tornare a casa. Esplorando i confini della città, al limite della zona “A”sotto controllo palestinese, vediamo ampie distese di alberi di ulivo con evidenti segni di mutilazioni e qualche tronco secco. Apprendo che i soldati israeliani ad ogni ricrescita ne ripetono il taglio, impedendo così la maturazione delle olive che per molte famiglie palestinesi costituiscono la sola fonte di reddito. Israele vuole così proteggere i coloni ebrei della zona “B” a controllo misto, dai palestinesi che potrebbero nascondersi fra gli alberi per colpirli. Intanto si cannoni israeliani che dagli insediamenti colpiscono la città di Ramallah, con i loro missili. Ad Est, come ad Ovest sui muri del Gran Park Hotel, dimora notturna dei soldati palestinesi, osserviamo tracce di missili lanciati dagli insediamenti ebraici posti a ridosso della cosiddetta zona autonoma. Israele si riserva, inoltre, il diritto di violare lo spazio aereo palestinese, a volte anche con gli F16, giacché i confini tracciati dagli accordi sono solo quelli di terra.
Riflessione personale: La giovialità e la voglia di vivere dei bambini in spiaggia, come di quelli sottoposti ad una vita blindata nei campi, sono un’autentica testimonianza dell’integrità morale di questo popolo. Grazie alla sua pazienza lungimirante e al suo carattere indomito, saprà certamente superare la delusione, la rabbia e persino l’odio per le umiliazioni che continua a subire da chi, in violazione di ogni principio di legalità internazionale e di ogni decisione di condanna delle Nazioni Unite, lo tiene sotto occupazione da oltre 50 anni. Lo stato d’Israele, nato da un popolo di sopravissuti adotta, perfezionandoli, gli stessi metodi nazisti di cui gli ebrei sono stati vittime. L’olocausto, strumentalizzato e asservito alla logica di un potere che chiede vendetta, non può essere sbandierato a giustificazione delle atrocità che l’esercito israeliano commette quotidianamente contro il popolo palestinese. Quel popolo che ha la sola colpa di aver dato spazio, suo malgrado, ai primi focolai di ebrei, sotto la spinta di un sionismo dilagante. L’occidente cristiano, in seno al quale l’olocausto è stato ideato e compiuto, forse per lenire il suo senso di colpa, oggi si rende complice più o meno silenzioso di un altro olocausto. Quello del genocidio del popolo palestinese, la cui eliminazione è stata progettata da Israele fin dalla sua nascita nel ’48 e da lui portata avanti in maniera progressiva col sostegno e la complicità di molti. La pace non resterà un’utopia se basata sulla giustizia!
Agnese Manca