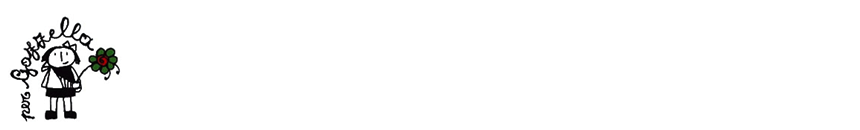Diario del XX viaggio
Cari amici di Gazzella,
anzitutto mi presento: mi chiamo Francesco, ho 27 anni, sto per laurearmi ed ho già trascorso due passate estati in un campo di lavoro in Palestina. Questo è il resoconto del mio terzo viaggio, il primo che ho intrapreso come volontario dell’associazione, una sorta di piccolo diario.
Purtroppo non ho potuto raggiungere la Striscia di Gaza, e dunque ho concentrato le mie visite in Cisgiordania. In una decina di giorni sono riuscito a visitare gran parte dei bambini ‘adottati’ in questa regione.
Le famiglie hanno ricevuto due rate di aiuti economici dalla nostra associazione, l’ultima delle quali all’inizio di quest’anno. L’aiuto di Gazzella è un piccolo aiuto ma estremamente importante. Molte famiglie sono riuscite a pagarsi le spese sanitarie e riescono a sopperire alla mancanza di lavoro e di cibo grazie anche al nostro sostegno.
Fondamentale, ovviamente, è anche la presenza fisica sul territorio, mia stavolta, ma soprattutto dei volontari che mi hanno preceduto, di cui peraltro molte famiglie mi hanno chiesto notizie, a riprova del legame di stima e di affetto che si viene a creare. Le visite alle singole famiglie dei bambini feriti rappresentano un atto di solidarietà politica, ma soprattutto umana, esteso a tutta la popolazione palestinese che soffre guerra e occupazione da quasi 60 anni.
Dal mio punto di vista, comunque, ogni famiglia con l‘accoglienza che mi ha riservato, i sorrisi e la forza di spirito mi ha donato certamente più di quanto io potevo donare loro con la mia presenza. Potrà apparire una riflessione banale, ma è significativa di tutto il viaggio che ho compiuto nei Territori Occupati.
Nablus
Il mio ‘giro’ è iniziato dalla città di Nablus e più precisamente dal check-point di Huwwara, principale ingresso alla città. Ho superato il check-point con facilità e quindi ho atteso i responsabili del Medical Relief con i quali avrei iniziato le visite alle famiglie. In 2 giorni abbiamo visitato 14 bambini sui 18 in adozione in questa città.
La situazione di Nablus mi è apparsa come la peggiore della Cisgiordania, sia per quanto riguarda la situazione dei bambini adottati, sia per il livello d’assedio cui la città è sottoposta quotidianamente. In tre giorni di permanenza sono stato testimone di tre incursioni dell’esercito. L’ultima, e la più pesante, è avvenuta di notte. L’esercito ha messo sotto assedio il campo profughi di Al ‘Ain, usando l’artiglieria pesante; nel corso degli scontri è rimasto ucciso il capo locale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina (FPLP). Per più di tre ore, ovvero dalle 2 del mattino fino all’alba, la città sembrava sotto bombardamento. La mattina seguente è stato per me sorprendente notare che molti abitanti della città avevano appreso la notizia della battaglia solo dalla radio, dalla televisione o dalla voce del muezzin. Il concetto di normalità in Palestina ha dei parametri molto diversi dai nostri: quella che per me è stata una notte di inferno per gli abitanti di Nablus è stata una notte come tante altre, da molti anni a questa parte, una notte “normale”. Le incursioni dell’esercito israeliano avvengono quotidianamente, le zone più colpite sono i quattro campi profughi e la città vecchia. I segni delle battaglie sono evidenti in queste zone della città: mura crivellate dai colpi, palazzi disastrati o interamente distrutti e crollati. Nella parte vecchia della città il crollo dei palazzi lascia dei vuoti “insoliti” all’interno dell’antica struttura architettonica, gli israeliani li hanno demoliti con l’esplosivo o addirittura bombardati con gli F16.
Molte lapidi ricordano chi è rimasto vittima di queste incursioni. Una di esse riporta i nomi dei membri di un’intera famiglia; la casa è stata fatta saltare in aria con tutti loro chiusi all’interno. Questo solo per permettere ai soldati un ingresso ampio nei stretti vicoli della città vecchia.
Il continuo stato d’assedio è dato anche dalla posizione della città. Essa è situata in una vallata circondata dai monti, sui quali ovviamente sono posizionate le basi militari dell’esercito israeliano. A chiudere il cerchio i numerosi check-point: Beit Iba, Huwwara, il 17, Beit Fouriq… uno più “problematico” dell’altro… Il check-point 17, ad esempio, è aperto solo al transito delle ambulanze, mentre al check-point che porta al villaggio di Beit Fouriq mi è stato negato il passaggio con l’ambulanza del Medical Relief. Non ho ma avuto così tanti problemi come ai check-point che circondano Nablus.
Ogni muro, ogni spazio di questa – come di altre città palestinesi – è ricoperto di manifesti degli uccisi, i “martiri”, come qui vengono chiamati. Non posso non soffermarmi sui loro volti: tantissimi sono giovani, adolescenti, alcuni di loro addirittura bambini. Un manifesto appare attaccato di fresco: leggo la data, 8 agosto. E’ un ragazzo presunto appartenente alla Jihad, assassinato dalle “forze speciali”, le teste di cuoio israeliane che, come in questo caso, agiscono perlopiù in borghese, penetrano nelle città palestinesi, colpiscono a sangue freddo e escono dai territori occupati coperti dall’esercito. Penso sia un atto criminale. Qualcuno mi racconta che quel ragazzo non era più ‘attivo’ da molti mesi, e forse era pure sulla ‘lista di Olmert’. Di recente, infatti, il governo israeliano ha pubblicato una lista di persone cui è stato tolto lo status di “ricercato”. Sono anche stati liberati 250 detenuti palestinesi, in accordo e in avvicinamento con il governo di Abu Mazen, governo nato in seguito alla presa di potere di Hamas nella Striscia di Gaza.
Queste iniziative sono state pubblicizzate in tutto il mondo per mostrare la volontà di pace d’Israele.
Sul campo però è tutta un’altra storia: non solo Israele continua a compiere i cosiddetti ‘omicidi mirati’, assassinando anche persone non più “ricercate” (che peraltro continuavano a vivere in clandestinità, conoscendo perfettamente il gioco dei sionisti) ma mi è stato raccontato che nella famosa ‘lista di Olmert’ sono state incluse persone che prima non erano affatto ricercate.
Nel corso della mia permanenza a Nablus ho anche raccolto l’atto di accusa di molte persone che criticano fortemente l’Autorità Nazionale Palestinese. Ovviamente il disastro in Palestina è il risultato dell’occupazione israeliana, ma una chiara responsabilità spetta anche all’ANP. Le accuse della popolazione non risparmiano nessuno, al di là degli schieramenti e dei governi succedutisi alla guida del popolo palestinese.
Mi rendo conto dello stato di tensione “interna” alla vista dei numerosi posti di blocco che la polizia palestinese ha collocato in molte parti delle città. Dopo quello che è avvenuto a Gaza l’Autorità Palestinese cerca di mostrare i muscoli e la città di Nablus paga e soffre per questa situazione. Dato che qui l’occupazione israeliana è molto più violenta, di conseguenza è molto più dura anche la resistenza, ‘islamica’ e non. La situazione a volte rasenta il ridicolo: i posti di blocco servono perlopiù a bloccare auto rubate. A volte capita anche che vengano arrestati membri di Hamas. Ho assistito ad un arresto del genere ed un amico mi rassicurava: “Tanto li rilasciano dopo qualche giorno, è solo per mostrare a quelli di Gaza che qui non si scherza”.
Ed è proprio un ragazzo appartenente a Fatah chi mi sottolinea la ridicolaggine di questa situazione e di questa polizia: “Stanno qui a fare i gradassi e poi quando arrivano gli israeliani si danno alla fuga, spariscono”.
Il campo di Balata è il più popoloso di Nablus ed è situato in una delle zone in cui maggiori sono stati i crimini compiuti dall’esercito israeliano.
Ho visitato Ahmad, colpito al collo da un proiettile e da allora rimasto invalido, e poi Abdelfattah raggiunto mentre era davanti alla scuola da un proiettile sparato da un carro armato. Mi mostra la ferita e mi racconta che credevano fosse morto, lo avevano portato all’obitorio, stavano addirittura per infilarlo in una cella frigorifera! Nell’osservare la ferita mi chiedo in verità come possa essere vivo con un buco del genere sulla schiena…
Poi ho visitato Basel, non ferito da un proiettile ma sbranato da un cane dell’esercito israeliano all’interno della propria casa e poi ancora Mahmud colpito da un proiettile alla testa è anche lui rimasto invalido.
Al di fuori del campo Balata visito Islam, colpito da tre proiettili: non proiettili comuni ma quelli che da queste parti chiamano “dumdum”, ovvero proiettili che all’impatto con il bersaglio esplodono. Se penetrano nel corpo sono praticamente mortali ed è un miracolo che lui sia ancora vivo. Adesso Islam vive sulla sedia a rotelle, con la spina dorsale divisa in due tronconi e necessita di un intervento altrimenti potrà vivere solo con l’ausilio della macchina per l’ossigeno. La famiglia mi consegna una delle ultime cartelle cliniche di Islam. Ogni famiglia ha delle richieste da fare ed io vorrei poter dare un aiuto, subito, a tutti, d’altra parte se è lecito fare una graduatoria dei “nostri” bambini palestinesi mi rendo conto che il caso di Islam risulta essere uno dei più gravi.
Ho visitato Zeid, ferito allo stomaco anche lui da un proiettile sparato da un carro armato. Fortunatamente è stato colpito solo di striscio. Questo episodio è avvenuto all’interno della città vecchia di Nablus. Mahmud, amico di Zeid, che era con lui, è rimasto ucciso: all’epoca avevano entrambi 10 anni. Poi ancora incontro Imad colpito (sempre nella città vecchia) da un “missile tattico” sparato da un elicottero Apache. Ovviamente l’ordigno è caduto a qualche metro di distanza ma lui in seguito all’impatto ha perso l’uso della vista. Aveva solo12 anni.
Quindi visito Ali e la sua famiglia. Mi accolgono dentro casa e mi rendo conto dell’estrema povertà nella quale vivono. Ali non ha un solo episodio da raccontare: è stato colpito più volte da “proiettili di gomma”, “proiettili vivi”, poi picchiato sulla testa con il calcio di un M16. I segni di questi crimini compiuti dall’esercito occupante sono ben presenti su tutto il suo corpo.
E ancora: incontro Ibrahim, ferito anche lui alla testa. I medici hanno utilizzato parti di pelle tagliata dalle gambe per suturare la ferita. In seguito ha subito altre operazioni, anche da parte di un gruppo di medici francesi. Come se non bastasse è stato ferito pure alla gamba, in un episodio distinto dal primo, accaduto di fronte la porta di casa. Anche Ibrahim e la sua famiglia vivono in condizioni di estrema povertà e la casa sono solo due stanze di pochi metri quadrati.
Il mio soggiorno a Nablus si conclude visitando la famiglia di Husam, che vive nel villaggio di Beta, distante dalla città pochi chilometri. Supero l’ennesimo check-point. Husam è con il padre in Giordania per subire l’ennesima operazione chirurgica. E’ stato colpito da 4 proiettili quando aveva 13 anni e da allora vive su di una sedia a rotelle. E’ stato sottoposto a numerosi interventi fino a quest’ultimo, necessario per l’insorgere di un’infezione. Le foto delle ferite che lo zio e i fratelli mi mostrano sul computer sono impressionanti. Non trovo parole.
Tulkarem
Superato il il check-point di Beit Iba trovo dall’altra parte Imad ad aspettarmi. E’ uno dei medici dello staf del Medical Relief di Qalqiliya. Imad parla perfettamente italiano perché ha studiato a Roma per molti anni. Con lui raggiungiamo Tulkarem dove visito la clinica del MR: è molto ben organizzata anche se di modeste dimensioni. Dopo una breve pausa e il consueto tè di benvenuto, inizio il giro nella città.
Visito tutti e 5 i bambini di questa zona, tra cui due bambine, Barah’ nel campo profughi Tulkarem e Iman nel campo profughi di Nur el-Shams, la prima colpita da un proiettile di gomma e la seconda dai frammenti di un colpo di artiglieria sparato all’interno della sua casa.
Mi preme sottolineare che quando parlo di “proiettile di gomma” si deve intendere un tipo di proiettile che “di gomma” ha solo il rivestimento: all’interno presenta da un corpo di acciaio. Anche se questi proiettili non sono così pericolosi e letali come i proiettili veri, possono però risultare fatali se vengono sparati dalla cintola in su e, soprattutto, se lo si fa a distanza ravvicinata. Due combinazioni che i soldati israeliani prediligono.
Continuo le mie visite a Tulkarem recandomi nella casa di Muhammad, colpito, anche lui, da un proiettile di gomma che gli ha causato la perdita di un occhio. Visito Ahmad, l’ennesimo caso di bambino colpito alla testa, anche lui miracolosamente sopravvissuto. Ha subito numerose operazioni e adesso vive con delle placche di titanio in testa. Data la giovane età Ahmad, come altri bambini, ha avuto un tempo di ripresa molto rapido e in effetti non vive più sulla sedia a rotelle e riesce a camminare anche se con molta fatica. Il suo stato sia fisico che mentale resta comunque molto grave.
Concludo il mio giro a Tulkarem visitando Hamed, nel villaggio di Kafr ‘Abbush.
Hamed ha appena 6 anni ed è il più piccolo fra i ‘bambini di Gazzella’ in Cisgiordania. Un giorno di due anni fa si trovava assieme alla sua famiglia al check-point vicino al suo villaggio: erano tutti in attesa di passare, diretti a Nablus. I soldati hanno iniziato a sparare gas lacrimogeno che, come qualsiasi cosa in dotazione dell’esercito israeliano, ha un livello di nocività maggiore rispetto a quello usato in Europa, violando come sempre il concetto di “legalità internazionale”. Hamed sotto l’effetto di questo gas è caduto, fratturandosi entrambe le gambe.
Saluto Hamed e la sua famiglia e ritorno verso Nablus. Lungo la strada che da Tulkarem porta a Nablus noto un discreto movimento di mezzi israeliani. Incrocio una colonna di jeep dell’esercito e al check-point di Beit Iba noto anche la presenza di mezzi pesanti e bulldozer. In effetti gli israeliani si preparano a invadere la città: quel giorno compiranno due ‘operazioni’, il pomeriggio stesso e la notte successiva, la normale “guerra notturna” accennata sopra.
Jenin
A Jenin i bambini sostenuti da Gazzella sono distribuiti su un’area più vasta.
Lo staff del Medical Relief di Jenin, a differenza di quello di Nablus, ha deciso di operare nei villaggi piuttosto che nella città o nei campi profughi. In Palestina casi di bambini feriti se ne contano a centinaia, se non a migliaia. Non vi è zona in cui non si conta un caso di un bambino ferito, mutilato, che ha subito le conseguenze dell’occupazione israeliana. Non vi è famiglia che non conosca o che non abbia subito direttamente casi del genere.
Il responsabile del MR mi spiega che dopo il massacro dell’aprile 2002 avvenuto nel campo profughi di Jenin tutte le attenzioni delle ONG e dei volontari internazionali si sono concentrate su questo campo, così loro hanno preferito portare aiuto anche nei villaggi più lontani, più isolati e di solito considerati meno dalle organizzazioni locali e internazionali.
In due giorni, i responsabili del Medical Relief ed io, maciniamo molti chilometri visitando una decina di bambini, sparsi in tutta la regione nord della Cisgiordania. E ho modo di rendermi conto che la situazione nelle campagne non è migliore di quella dei campi profughi.
Visitiamo Rawand e la sua famiglia. Sono molto poveri. Rawand e la sorella sono disabili dalla nascita. Lei è stata colpita da un proiettile di gomma mentre era in casa.
Poi incontro Ali. Il bambino è di origine beduina e vive in una tenda con la sua famiglia. Impieghiamo circa un’ora prima di riuscire a localizzare il luogo dove attualmente soggiornano. Anche se Ali e la sua famiglia non vivono nel classico campo profughi dell’UNRWA, anche loro sono profughi del ’48. La famiglia è originaria di Haifa. Sono pastori-beduini, diversi dai classici beduini del deserto. Il padre mi intrattiene parlando della Sicilia, del Vesuvio e addirittura di Aldo Moro. A differenza di molte altre famiglie da me incontrate, conoscono a perfezione la data in cui è avvenuto il ferimento del figlio e l’età di tutti i loro figli, cosa che a noi sembra normale ma che qui è da considerare una curiosità di cui prendo nota.
Proseguo il mio giro e visito Shahada. Nel 2003, quando aveva 11 anni, ha perso una gamba saltando su una mina; oggi riesce a camminare grazie a una protesi. Lui e suo fratello erano nei pressi della loro casa, giocavano per strada, e sono rimasti incuriositi dalla mina che non hanno riconosciuto poiché aveva la forma di un pallone.
Nel villaggio di Rummane, situato vicino alla linea verde, visito Nur e Muhammad.
Proseguo poi il giro visitando Mujahed, ferito alla gamba da un proiettile e Abdallah colpito alla testa da un proiettile di gomma. Il soldato ha mirato contro Abdallah, quando lui aveva solo 11 anni, per ucciderlo; colpire alla testa a pochi metri di dastanza con un proiettile di gomma significa infatti voler uccidere. Anche Abdallah ha subito molte operazioni e di fatto il suo stato di salute è simile a quello dei bambini colpiti alla testa da un vero proiettile.
Infine le ultime visite nella città di Jenin e nel suo campo. Incontro Muhammad, investito dalla deflagrazione di una bomba o di una mina lasciata dai soldati durante l’invasione dell’aprile 2002. Ha subito di recente un’altra operazione ed ha una vistosa fasciatura sul viso. Anche il fratellino più piccolo è stato colpito nella stessa circostanza e il suo volto è completamente ustionato. Avevano rispettivamente 6 e 2 anni.
Sempre a Jenin visito Uday colpito in faccia da un proiettile che fortunatamente lo ha trafitto nella parte della bocca non ledendo punti vitali. E infine incontro Saqer, ferito alla gamba dall’ennesimo proiettile di M16. Ha un grosso buco lasciato dal proiettile; il padre mi racconta che ha rischiato l’amputazione. Saqer e la sua famiglia vivevano nel campo Jenin ma, in seguito al massacro compiuto dagli israeliani nell’aprile 2002, al ferimento del bambino e soprattutto all’uccisione di 3 suoi cugini e della nonna, la famiglia ha deciso di scappare dall’inferno del campo. A causa di queste tragedie ovviamente tutta la famiglia è profondamente provata soprattutto dal punto di vista psicologico.
Anche a Jenin non ho potuto visitare un bambino data l’impossibilità di raggiungere il suo villaggio: Barta’a. La storia del villaggio di Barta’a è davvero unica e vale la pena accennarla. E’ stato tagliato in due nel ’48 dalla linea verde, per cui la parte all’interno della Cisgiordania è diventa Barta’a al-sharqiyye ovvero Barta’a Est. Attualmente è tagliato fuori dal resto dei territori palestinesi dal Muro che, virtualmente lo ha riunito alla sua parte ovest ma, in pratica, lo isola sia dal territorio israeliano che dal territorio palestinese. Si trova nella cosiddetta “no man’s land” ovvero nella zona militare israeliana.
Finite le visite a Jenin si torna a Nablus. Ora non mi resta che andare verso sud, verso Hebron.
Verso Hebron
Saluto con calore lo staff del Medical Relief di Nablus con la speranza di poterli incontrare al più presto. A voi sostenitori di Gazzella voglio rendere testimonianza di quanto questa gente sia straordinaria. Sono persone veramente uniche. Lavorano in emergenza 24 ore su 24. Ogni qual volta l’esercito israeliano occupa la città, loro devono essere pronti ad intervenire e, ovviamente, non sanno quando questo potrà accadere, se di giorno, o di notte; a volte ci sono più incursioni in uno stesso giorno. Mi hanno raccontato che qualche anno fa, negli anni più cruenti di questa seconda intifada, l’emergenza è durata 18 giorni. Hanno passato diciotto giorni senza tornare alla loro casa, senza pensare a mangiare o a dormire, sempre al lavoro, seguendo l’esercito israeliano e la loro scia di morte e distruzione. I due autisti dell’ambulanza hanno subito entrambi delle ferite d’arma da fuoco riportate mentre compivano il loro lavoro. Uno è stato ferito mentre soccorreva altri feriti, l’altro ferito alla guida dell’ambulanza. La stessa ambulanza è stata alla fine rottamata, resa inagibile dalle tante battaglie combattute faccia a faccia con l’esercito.
Ognuno di loro ha storie incredibili alle spalle. Ancor più incredibili perché a subire le violenze è personale medico che dovrebbe essere protetto da leggi e convenzioni internazionali. Sono sempre in prima linea, insieme al personale della “Mezzaluna rossa”, ad altre Società Mediche, a molti volontari… Non ho potuto trattenermi dal far loro una domanda: ”E quelli della Croce Rossa?”, ho chiesto. “Dormono”, mi hanno risposto. “Sono quelli che hanno più potere ma non si muovono; invece di sfruttare questa prerogativa per arginare le violenze degli israeliani, restano fermi, chiusi nel loro ufficio e scrivono report, scrivono report, scrivono report…”
La prassi è questa: quando c’è un’emergenza la Croce Rossa chiama l’autorità israeliana per chiedere il permesso di poter intervenire, sono gli unici che hanno il potere di farlo. Israele, ovviamente, non concede il permesso, blocca tutto e dichiara la zona sotto assedio “area militare”. A quel punto la Croce Rossa obbedisce e resta ferma, ma gli altri si muovono, non rispettano l’ordine e vanno a recuperare i morti e i feriti, rischiando però di venire colpiti dal fuoco israeliano, che non ha pietà verso coloro che hanno violato “l’area”.
“Se la Croce Rossa si muovesse, gli Israeliani comunque non la colpirebbero”, mi dicono indignati. O perlomeno sarebbero in parte frenati dal compiere i crimini umanitari che solitamente compiono.
Guardo la macchina del Medical Relief allontanarsi e tornare nell’inferno di Nablus e mi appresto a passare il check-point di Huwwara, per lasciare la città palestinese. Entrare a Nablus è risultato facile, uscire sarà molto dura. Mi faranno uscire poi, ma non senza crearmi numerosi problemi e facendomi pesare il fatto che: … se vuoi entrare, fai pure… a tuo rischio e pericolo!.. ma non pensare di poter uscire facilmente… Ho passato un’ora e mezza di attesa, in compagna di un soldato che mi vorrebbe rinchiudere in un buggigattolo che loro usano come cesso! Cerco di origliare i discorsi dei soldati. Non conosco l’ebraico ma cerco di cogliere, in base al contesto, l’argomento del dialogo. Sembrano molto interessati al mio ‘caso’ ma, alla fine, me – come si suol dire – me la cavo: per me solo attesa e tanta pazienza.
Prendo un taxi collettivo diretto a Ramallah e da lì ne prendo un altro per Betlemme. Percorro la strada che tutti chiamano Wadi Al Nahr. Potrei passare per Gerusalemme, sarebbe più rapido, ma preferisco fare “la strada dei palestinesi”, un po’ per solidarietà, un po’ a causa dei numerosi problemi che ultimamente ho avuto ai check-point. Entrare a Gerusalemme risulterebbe più complicato, dovrei superare il check-point di Qalandia, che nell’arco di un solo anno ha subito un cambiamento mostruoso e ora somiglia ad una frontiera internazionale.
Così faccio la strada che tutti i palestinesi fanno per andare dalla parte nord alla parte sud della Cisgiordania, aggirando Gerusalemme, metà proibita per loro, i palestinesi.
Si transita per una strada più grande che costeggia l’insediamento di Male Adumin, usata anche dai coloni. A dire il vero questa è la cosiddetta “strada dei coloni”. Poi si percorre una “strada per arabi”, piuttosto tortuosa, tutta curve e tornanti. In un ora e mezza, massimo due, se non si hanno problemi al check-point “Container”, ( punto d’ingresso a sud), si arriva a Betlemme. Bisogna ricordare che Ramallah-Betlemme, in linea d’aria, distano solo qualche chilometro.
Il tassista mi dice che dal prossimo anno la strada a scorrimento veloce, quella che costeggia l’insediamento di Male Adumin, verrà interdetta ai palestinesi. Gli israeliani stanno costruendo una nuova strada solo per i palestinesi, in modo da isolarli e segregarli ancora di più. Questo vorrà dire anche più tempo per percorrere pochi chilometri, ancora più isolamento tra il cantone sud dei territori palestinesi e i cantoni del nord. Senza poter transitare sulla cosiddetta “strada dei coloni” sarà inoltre complicatissimo raggiungere Gerico dal sud e questo prenderà molte ore. Ma, soprattutto, tutti questi cambiamenti significano nuovi terreni confiscati, metri e metri di terra rubati ai palestinesi, tutto il tratto che va da Qalandia fino a Male Adumin inglobato nella colonia – la più grande della Cisgiordania – e inglobato quindi nella Grande Gerusalemme Ebraica, nuova terra per la Grande Israele. Ma, prego, non chiamiamola apartheid… questi sono i preparativi dello stato israeliano al nuovo piano di pace.
Hebron
Trascorro la notte a Betlemme e il giorno dopo mi dirigo a Hebron: un altro taxi collettivo, altri check-point e altre colonie che costeggiano tutto il tratto che va dalla città natale di Gesù alla città di Ibrahim al-Khalil, ovvero Abramo.
Arrivato in città incontro i responsabili del Medical Relief e inizio subito le visite. Anche ad Hebron i bambini sono localizzati su un’area piuttosto ampia: impiegherò due giorni per visitare tutti i 10 bambini ‘adottati’ in questa zona.
Le prime sono tre bambine: Dia’, Nisreen e Bisan, che abitano nel campo profughi di Al Fawwar situato a una mezz’ora di macchina a sud di Hebron. Dia’ è stata colpita al volto da una bomba sonora. E’ un tipo di arma usato per disperdere e stordire ma la cui vicinanza può risultare fatale. Nisreen, invece, è stata colpita da un proiettile di gomma al collo e Bisan colpita al volto e agli occhi dai frammenti di un colpo sparato da un carro armato. All’epoca aveva 7 anni ed era il periodo delle operazioni criminali di Sharon denominate “scudo di difesa”.
Nella regione di Hebron e più precisamente nelle campagne attorno al villaggio di Dura visito altri 4 bambini: Nureddin, Sa’eq, Saifeddin e Bahir. Sa’eq e Bahir colpiti alla testa da proiettili di gomma, Nureddin ferito ad entrambe le gambe da due proiettili e Saifaddin colpito da più proiettili di gomma in uno stesso momento. Tra le tante armi usate dagli israeliani vi è infatti la classica bomba a grappolo, adattata ai proiettili di gomma: in un solo colpo vengono liberati 15 di questi proiettili (biglie ricoperte da un sottile strato di gomma) che colpiscono a caso in tutte le direzioni.
Questi 4 bambini hanno in comune il fatto di essere stati feriti mentre andavano a scuola, come d’altra parte la maggior parte dei bambini da me incontrati, colpiti mentre andavano a scuola o all’interno delle loro abitazioni.
Nei dintorni del villaggio di Idhna visito Amira. Questa bambina è forse l’unica dei bambini adottati in Cisgiordania a non essere stata ferita dai soldati israeliani. Amira è rimasta ferita in seguito a un agguato dei coloni, compiuto di fronte casa sua. La storia è straziante.
Era il 19 luglio del 2001. Amira aveva solo 2 anni e mezzo, stava tornando a casa con la sua famiglia dal villaggio di Idhna, distante solo un paio di chilometri. Giunti di fronte casa hanno incrociato una macchina di coloni che ha aperto immediatamente il fuoco contro di loro. Anche in questo caso i proiettili sparati furono del tipo ad esplosione. Rimasero uccisi lo zio di Amira che aveva 21 anni, un cuginetto di appena 2 mesi e mezzo e un altro ragazzo sempre della stessa famiglia. La macchina dei coloni proseguì a tutta velocità raggiungendo immediatamente Israele, essendo la linea verde distante pochi chilometri dal luogo del massacro.
L’eccidio all’epoca non passò inosservato e i familiari di Amira mi raccontano che addirittura la Casa Bianca si scomodò, porgendo loro delle scuse (sic). Forse il motivo di tanto interesse dipese dal fatto che proprio in quel periodo erano in corso i preparativi per l’ennesima conferenza sul Medio Oriente, forse un avvenimento del genere risultò piuttosto ‘noioso’ per i fautori del Nuovo Medio Oriente.
A raccontarmi i fatti è il nonno di Amira che nel massacro compiuto dai coloni ha perso il figlio e il nipotino neonato. Non traspare emozione dalle sue parole, non una lacrima, forse non ne ha più, le ha spese tutte. Mi parla in un perfetto inglese – a volte inusuale da queste parti -. Mi racconta tutto del massacro, particolare dopo particolare e, infine, mi mostra la lapide posta sulla strada a memoria dell’eccidio compiuto dai criminali sionisti. Trova pure il tempo e la gentilezza di parlarmi dell’Italia, sapendo che vengo da lì. Lui è stato a Bari nel ’97 per comprare una macchina per raccogliere le olive. Ricorda con nostalgia quel periodo, perché anche se non c’era la pace perlomeno si lavorava, si viveva, mi dice. Lo saluto e mi scuso per avergli fatto rivivere quei momenti terribili. Mi sorride, mi porge la mano, e anzi mi dice che per lui è un bene ricordare… Io non trovo le parole, quasi mi vergogno, salgo in macchina, ripartiamo.
Non facciamo in tempo a percorrere qualche metro che proprio nei pressi dell’incrocio di fronte alla casa di Amira noto un discreto movimento: mezzi da lavoro, camion, scavi, tubature, i classici lavori in corso. Si svolgono sotto l’attenta sorveglianza di una jeep di soldati e la presenza anche di qualche colono. Al responsabile del Medical Relief chiedo di cosa si tratti; mi dice che stanno compiendo dei lavori al sistema idrico, stanno deviando i corsi d’acqua che provengono da Beit Jebrin (villaggio palestinese al di là della linea verde, distrutto nel ’48 dai sionisti, colonizzato e convertito nel nome di Bet Govrin) per incanalarli verso le colonie, e tagliare quindi le risorse d’acqua al villaggio di Idhna. E tutto questo a pochi metri da quella lapide…
L’ultimo bambino da me visitato è Hani, nel villaggio di al-Karmil nell’estremo sud della Cisgiordania. Nelle vicinanze di questo villaggio c’è una base militare israeliana, un giorno Hani era al pascolo con le pecore e proprio nei pressi della base è rimasto investito dalla deflagrazione di una mina. Uno dei suoi fratelli è rimasto ucciso, un altro ferito in modo non grave. Hani invece è stato colpito principalmente allo stomaco. E’ rimasto molti mesi in ospedale e ha subito ben 8 interventi chirurgici. La ferita ha lasciato dei segni impressionanti che il bambino mi mostra senza imbarazzo. Con Hani concludo le mie visite a Hebron e con esse il mio viaggio in Cisgiordania.
Torno verso nord, mi trattengo qualche giorno tra Gerusalemme e Betlemme per poi ripartire per l’Italia. Un ultimo ostacolo, l’areoporto Ben Gurion, con i suoi interrogatori, che risultano per fortuna più semplici di altre volte.
Prima di concludere questa sorta di diario, vorrei sottolineare una mia riflessione.
Una volta tornato ho passato molti giorni a ripensare, a confrontare le storie di tutti questi bambini, storie molto simili fra loro. Ho tentato con la mia mente di collocarle nel passato, un passato recente ma comunque passato. Poi (errore) ho provato a buttar giù una statistica (vizio tipicamente occidentale) e ho notato che la maggior parte dei bambini è rimasta ferita durante gli anni più duri dell’attuale intifada, ovvero il 2002 e il 2003. Ma sistematizzare non ha funzionato. Anche la primavera dello scorso anno non è stata da meno, quando, all’indomani della vittoria di Hamas, Israele ha compiuto “punizioni collettive” contro tutto il popolo palestinese.
In effetti questi miei pensieri sono risultati vani, e le notizie che provengono dalla Palestina mi risvegliano e mi riportano alla realtà, la realtà violenta dell’occupazione israeliana.
Il 4 settembre scorso a Nablus durante un’invasione dell’esercito israeliano che ha coinvolto 30 veicoli militari, Rami, un bambino palestinese di 8 anni è stato colpito alla testa da un “proiettile di gomma” e versa in gravi condizioni. Altri due bambini, di 14 e di 15 anni, sono stati colpiti nello stesso episodio riportando ferite meno gravi.
A Jenin il 6 settembre la stessa storia: l’esercito invade la città e lascia dietro di sé 2 bambini feriti. Uno, colpito da un “proiettile di gomma”, non è grave ma è stato operato per poter rimuovere il proiettile (di gomma!) dal suo corpo. Un altro invece versa in gravi condizioni ed è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale israeliano, segno della gravità del caso.
Scrivo questo per sottolineare che ogni singola storia da me raccolta si ripete quotidianamente, le sofferenze che ho condiviso con ogni singola famiglia coinvolgono adesso nuove famiglie, i casi di altri bambini feriti si ripetono e con loro si moltiplicano i dolori del popolo palestinese.
In Palestina non esiste un periodo più tranquillo di un altro, la tranquillità è un concetto relativo e finisce non appena una jeep dell’esercito entra nel campo e comincia a sparare; non esiste un periodo migliore di un altro, non esistono statistiche e numeri ma esiste solo uno stato di guerra permanente, continuo, che non ha logica e che serve a corrodere le speranze dei palestinesi e la loro tenacia nel resistere e nel sopravvivere. Una guerra di annientamento costruita dai sionisti giorno per giorno, centimetro su centimetro.
E’ proprio la mancanza di logica a dare a volte un senso di frustrazione psichica ai palestinesi.
E se una logica c’è, di fatto questa è proprio quella dell’annientamento. Un tipo di annientamento più evidente, come quello portato avanti nella Striscia di Gaza, o quando avvengono le grandi operazioni di guerra, oppure un tipo di annientamento più nascosto, quotidiano, ingannevole, psicologico, perpetrato nei periodi considerati (e da noi spacciati come) di relativa calma, ma in realtà saturi di tensione continua, che consuma l’esistenza dei palestinesi. Erode la voglia di vivere.
La situazione è drammatica. Ma, bizzarramente, sono stati proprio loro, i palestinesi che ho incontrato a darmi speranza. Nonostante tutto resistono. Mi hanno fatto ricordare le parole di un giovane partigiano diciottenne, fucilato dai fascisti. “… verrà un giorno “ – scriveva nel suo ultimo pensiero – “che il cielo tornerà azzurro, le mamme non piangeranno e le ragazze riprenderanno a sorridere…. Non commiserate la mia sorte, voi avrete un mondo migliore…”
Francesco