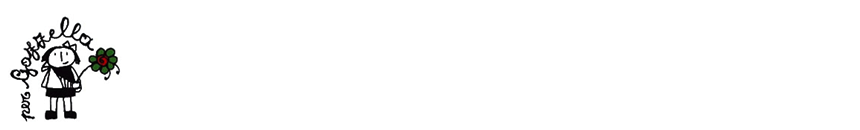Angelo d’Orsi su Micromega – 21 novembre 2012
Articolo pubblicato su: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/11/21/angelo-dorsi-le-immagini-di-gaza/
 Guardo le foto. E mi sembra un macabro scherzo. Guardo le foto. E non riesco a crederci. Le riguardo, mi soffermo sui volti color cenere, le macchie della pelle, gli occhi ora sbarrati, ora socchuisi, ora, infine, chiusi e destinati a mai più riaprirsi. Le foto dei bambini di Gaza.
Guardo le foto. E mi sembra un macabro scherzo. Guardo le foto. E non riesco a crederci. Le riguardo, mi soffermo sui volti color cenere, le macchie della pelle, gli occhi ora sbarrati, ora socchuisi, ora, infine, chiusi e destinati a mai più riaprirsi. Le foto dei bambini di Gaza.
Quelli più grandicelli – forse 7-8 anni – sono rivesti della bandiera della Palestina, quelli più piccini, in verde islamico, con decorazioni; i neonati fasciati da lenzuolini bianchi, piccoli sudari. Guardo i volti severi, composti, pieni di dolore contenuto, dei loro genitori; una di queste immagini rappresenta un corteo funebre. Due corpicini portati delicatamente tra le braccia dei loro padri: un terzo uomo (sono tutti molto giovani), al centro, regge le teste, le piccole teste, ricoperte da un velo candido; sono i corpi senza vita di Jumana e Tamer, la cui vita è stata fermata prima che raggiungesse il quarto anno. Gli uomini camminano, non piangono, non mostrano neppure odio, ma intuisci dietro le maschere facciali, ferme, come inerti, intuisci disperazione: un’assoluta, semplice disperazione.
Ma la disperazione può trasformarsi, un giorno o un mese dopo, in rabbia: una rabbia che non può avere perdono, una rabbia che nulla potrà placare. Quando ti ammazzano un figlio, una creatura di quattro mesi, o di quattro anni, come puoi accettarlo? E continuare a tacere? E quando l’assassino è il tuo oppressore, è colui che ti ha scacciato dalla tua terra, chi ha spiantato il tuo uliveto, per farci passare un muro alto come un grattacielo, chi devia il corso dei fiumi per rubarti l’acqua, chi ti costringe a quattro ore di coda, sotto il sole, per superare un punto di controllo militare, per raggiungere un posto di lavoro…
Quando il colpevole è colui che sta assassinando da troppi decenni la tua gente: ebbene, come puoi chinare il capo, e continuare a subire? Quando chi ti ammazza i figli, le mogli, i genitori, chi bombarda le poche strutture di una città – Gaza City – che in un fazzoletto di terra racchiude una intera umanità, alla quale viene negato il diritto stesso alla sopravvivenza, ebbene, come puoi pensare che quelli – gli israeliani, gli ebrei occupanti che ti hanno devastato la vita e non solo rubato la patria – vogliano vivere in pace al tuo fianco? Come puoi credere che siano pronti a riconoscere i diritti del popolo di Palestina?
E allora ecco che, una volta sepolti quei poveri corpi martoriati dalle bombe spesso “condite” di materiali vietati dalle convenzioni internazionali (di cui altamente la democratica Israele si infischia), la disperazione divenuta rabbia esplode; ecco la rabbia farsi essa stessa arma. Nulla può fermare quel flusso che sorge dal profondo, e non cerca altro che di venire fuori, di dirigersi contro quegli stessi che hanno assassinato la tua gente, e quando la rabbia è tanta, ma proprio tanta, diventa furore cieco. E chi ne è travolto non sta più a distinguere, a meditare, a interrogarsi su quali siano gli obiettivi giusti da colpire. Colpisce e basta. E quando non hai altre armi anche il tuo stesso corpo può diventare tale. Il kamikaze non è come scrisse in un libretto sciocco Enzserberger il “perdente radicale”. Il kamikaze è l’umiliato che prova a conquistare un’estrema dignità. Non è un vile: vile è il cecchino, è colui che mette la bomba nel cestino, o lascia una valigetta con il tritolo e si allontana e muove un congegno quando è al sicuro, e uccide, alla cieca. Non è un frustrato che vuole passare alla storia: è un disperato che preferisce la morte, dando la morte, piuttosto che accettare la “morte lenta”. Edward Said, dopo una visita a un campo profughi palestinesi, proprio nella Striscia di Gaza, scriveva:
Il campo di Jabalya è il posto più spaventoso che abbia mai visto. I bambini che affollano le sue viuzze non lastricate, caotiche e piene di buche, hanno negli occhi una luce che contrasta nettamente con l’espressione di tristezza e sofferenza infinita stampata sui volti degli adulti. Non esiste una rete di fognature, il fetore dà il voltastomaco, e ovunque si volga lo sguardo si vede una massa di persone vestite di stracci passare con apparente indifferenza da un’occupazione a un’altra. Le statistiche sono terribili: il tasso di mortalità più elevato, la maggior percentuale di disoccupazione, il più basso reddito pro capite, il maggior numero di giorni di coprifuoco, l’assistenza medica più carente e così via. […] Nelle due ore passate con quegli uomini non ho colto una sola nota di speranza. Uno di loro, senza la minima traccia di autocommiserazione,
parla dei suoi diciassette anni di prigione, del bambino malaticcio, dei genitori e della moglie oppressi dalla malattia o dall’indigenza, con qualche raro momento di sollievo.
C’è molta rabbia. Un’espressione, che ricorre continuamente, mi rimarrà impressa per sempre: «mawt bati», morte lenta.
Torno alle immagini: una mi colpisce forse ancora più delle precedenti. Una stanza, foderata di tappeti, su uno dei quali una creaturina ricoperta di un bianco lenzuolo, sul quale una macchia rossa, ti fa capire che quel bimbo (Yhad, un anno) non dorme e non è morto di morbillo. È stato ucciso. Accanto a lui, a distanza di circa un metro, suo padre. È accoccolato sul tappeto. Ha lo sguardo sperso. Come a cercare qualcuno che gli parli. Aspetta una parola: non di conforto, ma di spiegazione. Che gli spieghi perché quella creaturina, di cui si intravede il volto semicoperto, bianchissimo, è stata strappata alla vita. Ma in fondo, dentro di sé, quel giovane padre, forse preferisce per i suoi bimbi, come per se stesso, anche la morte a quell’altra, la “morte lenta”, forse meglio la tragedia della morte improvvisa, violenta, al dramma dell’attesa, la morte che si consuma giorno dopo giorno, senza possibilità di salvezza, in una vita che vita non è.
I governanti israeliani, a quanto pare, sono misericordiosi. E stanno provvedendo a sostituire alla morte lenta, quella della fame e della miseria imposta dalla loro politica a una terra ricca come la Palestina, la morte rapida, generosamente dispensata dal cielo.
Chissà se il loro dio, il dio che ha chiamato “eletto” quel popolo e gli ha assegnato in perpetuità quella terra, è d’accordo. Chissà se collabora, e indirizza bene i droni che bombardano. O se non è invece un dio di giustizia che un giorno o l’altro farà cadere la sua collera sugli eletti.
Angelo d’Orsi