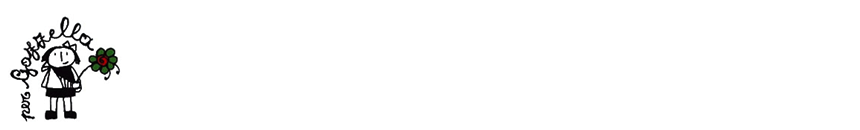Palestina, bambini senza libertà. Ennio Polito per Liberazione
Nella striscia di Gaza occupata, tempi brevi scandiscono l’inumano giro di vite sollecitato da Ariel Sharon nel “far soffrire” i civili palestinesi. La signora Agnese Manca, che aveva visitato la striscia l’estate scorsa per conto della rete di solidarietà “Per Gazzella”, ha trovato la situazione “di gran lunga, visibilmente peggiorata”. La confisca della terra, la distruzione delle case, la devastazione dei campi coltivati, delle infrastrutture e della rete stradale, il numero dei feriti e dei morti, le ore passate ai punti di accesso, per controlli minuziosi e sfibranti, o per mera esibizione di potere segnalano una sofferenza quotidiana “ai limiti del tollerabile”.
Siamo andati a incontrare la signora Manca a Fiumicino, al suo rientro da un viaggio movimentato, nel quale le è stata compagna Letizia Lindi, una dirigente dei giovani comunisti di Carrara. Anche il passaggio della frontiera, all’aeroporto di Tel Aviv, era stato caratterizzato da un carico maggiore di vessazioni poliziesche: lunghi interrogatori, perquisizioni personali, più lunghe ore in isolamento in sudici stanzoni, prima di una decisione che ha imposto il reimbarco della maggioranza dei più giovani. Vittime di un sospetto generalizzato, collegato all’idea che la sicurezza di Israele sia minacciata dall’esterno anziché dalla persecuzione della popolazione autoctona, altri membri della delegazione hanno dovuto così ripartire, ciò che ha fatto ricadere per intero sulle due donne la fatica dell’incontro con trecentocinquanta famiglie di bambini feriti, adottati a distanza. Due bambini sono stati uccisi nei mesi scorsi dai soldati e molti altri hanno perduto la casa, demolita in una delle tante “punizioni” individuali o collettive. I morti sono Murad, un ragazzo di Rafah, nel sud della striscia, ferito al capo, e Fadi, un bambino di dieci anni, di Khan Yunis, bruciato con i genitori e i fratellini nel rogo della loro casupola, nel campo profughi; dell’intera famiglia è sopravvissuto soltanto un ragazzo, del quale mancano notizie. I feriti non si contano. Si può essere feriti all’uscita di scuola, a un funerale, in una manifestazione, oppure giocando per strada. Nel resoconto che ci viene fatto c’è anche una nota lieta. In una casa del campo profughi di Jabalya la Manca aveva incontrato, nel suo viaggio precedente, una ragazzina sugli 11-12 anni che, traumatizzata da bombardamento, aveva perso la parola. Ora l’ha ritrovata. Si chiama Wafa, parla, è contenta di vivere.
Ma la felicità, nella striscia, è un genere introvabile. Il paesaggio tra Jabaya e Rafa, all’estremo sud, è infernale. Vecchi e nuovi ritrovati della tecnologia di distruzione israeliana, quasi sempre forniti dagli Stati Uniti, hanno lasciato il loro segno: i carri armati hanno aperto la via, i bulldozer hanno fatto il grosso del lavoro, davanti alle spianate dei campi profughi, dove giocano i ragazzi, sono apparsi i gulba, una sorta di torrioni insediati in posizione dominante o capaci di raggiungere tale posizione con una parte mobile, che sale e dalla quale, all’improvviso, aprono il fuoco le mitragliatrici. Tutto attorno, macerie, tubature dell’acqua tranciate, pali elettrici sradicati o pericolanti, cabine telefoniche schiacciate al suolo, campi rivoltati.
“Una quindicina di chilometri oltre il capoluogo, andando verso Khan Yunis, all’incrocio con la strada che conduce a un insediamento”, raccontano, “troviamo una lunga fila di macchine ferme, in attesa. Passano due ore, cariche di tensione. Molti siedono nelle vetture con le portiere aperte, altri sulle scarpate della strada polverosa, o sotto ripari di fortuna. Per gente che va al lavoro, in ospedale o a far visita a un parente, i soldati hanno cura di trasformare distanze di pochi chilometri in un viaggio snervante. A un tratto, sentiamo gridare: “Si passa!”. Tutti risalgono in macchina precipitosamente per tornare a fermarsi cinque minuti dopo. Da una gulba spuntano le canne delle mitragliatrici, passa un carro armato, seguito da un bulldozer, che rovescia sui viaggiatori nuvole di polvere”.
“Per evitare di perdere tempo con gli spostamenti abbiamo dormito quattro notti a Khan Yunis. Nel buio, ma spesso anche di giorno, risuonavano gli spari. A Rafah i muri delle case sono tappezzati di fotografie di martiri, per lo più giovani, uccisi mentre manifestavano contro il ritorno dei carri armati in città o soltanto per essersi avvicinati troppo ai nuovi confini, con i quali gli israeliani incamerano altri territori palestinesi. Decine di case continuano a essere distrutte in incursioni notturne e l’indomani, chi viene trovato sulle macerie rischia la vita”.
Molti di quelli che Agnese chiama “i nostri bambini” si sono dispersi dopo che le famiglie hanno perduto la casa. Cita, tra gli altri, Omar, di quattro anni, e Mahmud Yasser, di venti mesi. I due sono fratelli, figli di uno dei sei uomini uccisi nella loro automobile da un razzo israeliano, due settimane fa, il secondo attentato in pochi giorni. Nel primo, il padre e i due bambini erano rimasti feriti in varie parti del corpo. La madre è in attesa di un terzo figlio.
Chiediamo con quali sentimenti la gente viva questa nuova fase del dramma. “Chi ce ne ha parlato, lo ha fatto con civiltà, con dignità, forse anche con un po’ di rassegnazione. Ogni bambino, ci diceva a Gerusalemme il conducente di un taxi, ha il diritto di sognare, ma a me non è stato concesso. Sfollato nel ’48 da Bersheva, non ho nessuno e non possiedo niente. Noi non vogliamo annientare gli israeliani, ma loro vogliono annientare noi. Ho cinquanta anni e non ho mai vissuto un giorno da libero. Sono un democratico, credo nell’eguaglianza degli esseri umani e nel rispetto della dignità di ognuno. Per i miei figli non c’è futuro. Qui non si possono fare progetti per l’avvenire, neanche a breve scadenza. I nostri problemi non finiranno mai. Il mondo non sa e non vuole sapere”.
Ennio Polito, Esponente della rete di solidarietà “Per Gazzella” di ritorno da Gaza