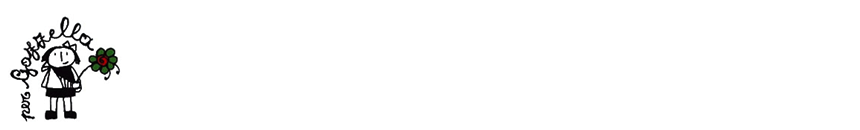In ricordo di Marina Rossanda
Marina Rossanda, Ghazala e “Gazzella”
di Wasim Dahmash
Quando fu eletta al senato, nel 1979, pensava di poter conciliare il nuovo impegno con il suo lavoro di medico. Così, per molti mesi Marina Rossanda ha viaggiato sui treni notturni tra Roma e Milano. Mi è capitato di fare qualcuno di questi viaggi in sua compagnia. L’avevo già incontrata qua e là in giro per l’Italia in occasione di conferenze o manifestazioni che l’allora PCI organizzava per sostenere la lotta di liberazione del popolo di Palestina, ma è stato durante quei viaggi notturni che la nostra amicizia si è consolidata. E a Roma, fin dal suo arrivo, Marina continuò a sostenere la resistenza palestinese prendendo parte della “Associazione di amicizia italo-araba” e del “Comitato nazionale di solidarietà con il popolo palestinese”.
Il suo impegno diventò più corposo e si istituzionalizzò dopo l’invasione israeliana del Libano, nel 1982. Nel luglio di quell’anno era andata a Damasco e da lì, con un tassì, voleva entrare a Beirut. Il tassista damasceno, per quanto impaurito, non si era comunque tirato indietro e l’aveva condotta per sentieri di montagna fino alla città assediata dalle truppe israeliane del generale Sharon.
Attraversate le linee era arrivata nella città sottoposta a un incessante bombardamento, aveva raggiunto l’ospedale “Gaza” e per tutta la durata dell’assedio aveva prestato la sua opera di medico anestesista. Così intendeva la solidarietà.
Al ritorno da Beirut, aveva fatto sviluppare le fotografie fatte in sala operatoria e per le strade della Beirut dell’assedio e dei massacri. Le fotografie di quell’umanità martoriata erano terrificanti. Le aveva scattate lei e quelle scene le aveva viste e vissute di persona. Guardammo insieme quelle immagini e chi scrive fu subito d’accordo con lei sull’opportunità di non mostrarle in pubblico, di non utilizzarle: erano davvero raccapriccianti. Certo, era necessario denunciare i criminali, ma senza de-umanizzarli. Quelle diapositive, che costituiscono un documento unico sulla vita quotidiana nei campi profughi di Beirut sotto assedio e sulle atrocità commesse ancora prima dei massacri di Sabra e Shatila, sono state depositate presso l’”Archivio Palestina” dell’allora “Fondazione Internazionale Lelio e Leslie Basso” in Via della Dogana Vecchia, al numero 5, a Roma.
Il coraggio che la spingeva a non retrocedere davanti alle situazioni estreme e di andare fin dentro il massacro, era fatto non solo di determinazione consapevole, ma anche di innata delicatezza. Quella delicatezza che le permetteva di non dimenticare, nel racconto di quanto aveva visto nell’inverno del 1987-88, nella Palestina della Prima intifada, di aver fotografato un uccello rarissimo che vive soltanto in quella parte del mondo o di portare da un vivaio di Gerico una piantina di olivo da regalare all’amico palestinese.
Fu dopo l’esperienza libanese, dopo i massacri di Sabra e Shatila, che fondò la “Associazione Medica Italo-Palestinese”. Mimma, come gli amici hanno imparato a chiamarla, ne è stata il motore e l’animatrice. Ben presto divenne strumento di sostegno alle istituzioni sanitarie palestinesi e alle associazioni di medici volontari che nei territori occupati gestiscono ancora la sanità pubblica sotto occupazione. Tra le iniziative intraprese dall’AMIP ci fu anche la pubblicazione di un giornale, «Balsam», che aveva il compito di informare, con notizie di prima mano, sulle condizioni sanitarie nei campi profughi palestinesi sparsi nel Vicino Oriente e nei territori occupati. Balsam uscì per alcuni anni in cartaceo e continua oggi in forma elettronica (www.palestina-balsam.it ; per le attività dell’AMIP si veda l’intervento di Sancia Gaetani in questo stesso volume).
L’impegno nell’AMIP porta Marina Rossanda a compiere ripetuti viaggi in Palestina, durante i quali elabora una mappa dettagliata dei gruppi, associazioni e singole persone che si occupano di sanità nei territori occupati. Con questi stabilisce rapporti di solidarietà e collaborazione: proficuo in modo particolare è il rapporto con la “Unione dei comitati di soccorso medico palestinese” (Union of Palestinian Medical Relief Committees), un’associazione di medici, presieduta da Mustafa Barghouthi, che prestano soccorso alla popolazione sotto occupazione e che con gli anni è diventata una grande organizzazione non governativa il cui nome è “Palestinian Medical Relief Society” (PMRS).
L’associazione ha creato un sistema di ambulatori, ospedali e cliniche mobili, che ha garantito e garantisce tutt’ora un livello minimo di sanità pubblica nei territori occupati. In lingua inglese, il sito della PMRS, www.pmrs.ps/last/index.php, ben organizzato, contiene utili informazioni sulle attività dell’associazione stessa e sulla situazione sanitaria nei territori occupati da Israele nel 1967.
I viaggi in Palestina erano sempre seguiti da un resoconto inviato a compagni e amici, in cui descriveva e spiegava le situazioni che man mano vedeva. Qualche volta le sue “relazioni di viaggio” prendevano forma di articolo che pubblicava su “Il manifesto”, “Balsam” o altri giornali. Costante e meticolosa, Marina aveva saputo tradurre in forme molteplici il suo impegno a fianco delle vittime dell’occupazione israeliana. L’ultima è quella rete di solidarietà che è oggi l’”Associazione Gazzella Onlus”, nata dalla collaborazione con la stessa PMRS. Nel 2000, insieme a Marisa Musu, era andata in Palestina. Durante quel viaggio, in un ospedale di Hebron aveva incontrato Ghazala (Gazzella), una ragazzina di 14 anni, in coma perché ferita alla testa da pallottole sparate da coloni israeliani mentre tornava da scuola. Ghazala è stata subito “adottata”. Al ritorno in Italia, Marina e Marisa avevano cercato di estendere la rete di solidarietà ad altri bambini palestinesi feriti da armi da guerra. Nasceva così l’Associazione “Gazzella” che oggi cura, con la formula dell’adozione a distanza, molti bambini feriti.
Nel ricordare Marisa Musu, scomparsa il 3 novembre 2002, Marina ripercorreva alcuni momenti della costruzione di “Gazzella” (Vedi l’articolo intero in
http://www.gazzella-onlus.com/marismus.html#marina):
Con Marisa ci eravamo trovate più di una volta in Palestina dopo la prima intifada, quando lei raccoglieva con suo marito Ennio Polito i dati per il loro libro sui bambini Palestinesi ed io lavoravo per collegare alcune ONG su progetti sanitari. Dal 1991 al 1995 si fece la rivista BALSAM, con lei Direttore responsabile.
Nel novembre 2000, un mese dopo lo scoppio della seconda intifada mi chiamò per propormi di andare noi due a riprender contatti e farci un’idea. Ne fui felice perché mancavo da alcuni anni. Trovammo un’atmosfera tesa. ma la solita testarda resistenza degli amici Palestinesi, che, pur più provati che in passato.ci accolsero con gioia e ci aiutarono a fare vari incontri. Fu all’Ospedale Ahli di Hebron, vedendo la ragazzina Ghazala ancora in coma per una pallottola israeliana in testa, che a Marisa venne l’idea della campagna per Gazzella, della quale i visitatori di questo sito sanno tutto. Avuta la conferma dei medici a smentita delle dichiarazioni dei militari che negavano di aver sparato alla ragazzina, e avuto il consenso della famiglia, la campagna partì e Marisa vi si gettò anima e corpo, nonostante i suoi molteplici impegni come ex-partigiana, una dei pochi ancora in vita del gruppo storico romano.
Val la pena rileggere oggi la “relazione” di Mimma scritta in seguito al viaggio compiuto in compagnia di Marisa Musu nel novembre 2000, pubblicata poi in forma di articolo su “La rivista del manifesto” (n.13, gennaio 2001), non solo per mettere in evidenza la genesi del progetto, ma anche per capire meglio la situazione esplosiva scaturita dagli accordi di Oslo e ciò che pensava Marina Rossanda in proposito (vedi l’articolo intero qui di seguito in appendice):
Sono tornata in Palestina alla metà di novembre, dopo cinque anni di assenza. Nonostante la nostalgia, salute e impegni mi trattenevano a Roma, e comunque, dagli accordi di Oslo in poi, non ero più motivata. Pensavo: i palestinesi hanno fatto la loro scelta, e se anche questa non mi convince, hanno diritto e magari buone ragioni per averla fatta, auguri di cuore, spero di sbagliarmi. Purtroppo non mi sbagliavo o almeno non interamente.
Non mi sbagliavo nel senso che il processo di pace si è trascinato per sette anni tra accuse e rinvii, e nel frattempo i governi israeliani hanno lavorato a creare situazioni di fatto compiuto, in barba agli accordi, consolidando e ampliando l’occupazione, mentre gli amici occidentali si beavano delle parole di pace.
Ovviamente le sue “relazioni di viaggio” avevano anche un aspetto “tecnico”. Oltre alle informazioni sulla situazione generale contenevano un dettagliato rapporto sull’attività svolta. Infatti, la rete di solidarietà si era allargata presto grazie al lavoro di Marisa, Mimma e un gruppo di compagni che non hanno risparmiato fatica e impegno. I bambini adottati, già nell’aprile 2001, erano 60 (Il rapporto intero si trova in http://www.gazzella-onlus.com/a012.html):
Come ci eravamo impegnati a fare, abbiamo portato e consegnato di persona ai ragazzi palestinesi feriti o ai loro familiari, nelle rispettive case nella striscia di Gaza, la prima rata del denaro raccolto e a loro destinato: l’equivalente di seimila dollari per sessanta bambini – cento dollari, pari a due mensilità, per ognuno di loro. Abbiamo pensato, infatti, conoscendo la terribile situazione nei campi profughi, che sarebbe stato opportuno consegnare a tutti la stessa somma e trattenere fino alla prossima consegna nel conto che abbiamo aperto in banca “Per Gazzella” il resto delle somme già versate da molti per l’intero importo (660.000 lire = 340,80 euro).
Le spese di viaggio per due persone (andata e ritorno in aereo, albergo a Gerusalemme, corse in auto da e per Gaza) erano totalmente a nostro carico. Per risparmiare abbiamo viaggiato con la compagnia greca Olympic piuttosto che con l’Alitalia (460.000 lire anziché un milione, ma non pochi disagi: soste ad Atene di otto ore all’andata e cinque al ritorno, arrivo a Tel Aviv e partenza da Gerusalemme, rispettivamente, alle tre e alle quattro del mattino). Per la prossima volta bisognerà trovare una soluzione diversa. Fortunatamente, a Gaza siamo stati completamente ospitati dalla Medical relief, organizzazione non governativa palestinese attiva da anni nei territori occupati sulla cui serietà ed efficienza avevamo ricevuto garanzie nell’ambiente medico italiano e palestinese. Il Medical relief ha pienamente risposto alle aspettative, ha perfettamente organizzato il nostro lavoro nei campi profughi e ci ha permesso di raggiungere e conoscere in due giorni le sessanta famiglie.
Essi avevano preparato per noi un elenco di sessanta nomi, scelti a uno a uno nei campi tenendo conto della gravità della ferita e della condizione sociale della famiglia; criteri indubbiamente più validi di quello genericamente seguito da noi a Roma, a tavolino, quando avevamo trascritto dall’elenco dei centocinquanta nomi in quel momento disponibili, una quota di sessanta. Abbiamo quindi accettato di procedere secondo le loro indicazioni e abbiamo suddiviso il denaro – in shekel, la moneta israeliana corrente nei Territori – che nei due giorni successivi abbiamo portato a destinazione. Siamo certi che i nostri sottoscrittori avrebbero fatto la stessa scelta e che quelli di loro che leggeranno nell’elenco un nome diverso da quello inizialmente selezionato comprenderanno e continueranno a sostenerci.
La rete di solidarietà si era allargata rapidamente e i viaggi dei volontari che andavano nei territori occupati per realizzare il progetto “Gazzella” si facevano sempre più frequenti. Al ritorno di un viaggio compiuto insieme a Sancia Gaetani nell’agosto 2001, Marina Rossanda scriveva un resoconto che dava il polso della situazione in Palestina e della rete di relazioni che “Gazzella” stava costruendo. Per dare un’idea delle attività e dei progetti sanitari che erano in corso o che si stavano programmando, ricordiamo, oltre a quella principale dell’adozione a distanza dei bambini feriti, dal resoconto di Marina sopra indicato, il passaggio relativo a Gazala, la ragazza ferita che aveva dato il nome al progetto, (il resoconto intero si può leggere in http://www.gazzella-onlus.com/a015.html):
Trovare la casa di Ghazala Jaradat, questo è il nome della nostra prima adottata, non fu del tutto facile; i Jaradat sono moltissimi a Saeìr. I nostri abitano con altri della famiglia in tre casette –semplici parallepipedi a un solo piano – in cima a una ripida collinetta spelacchiata, tutta sassi. Ci accolsero con la solita cordialità. Attesi di vedere Ghazala con ansia, negli occhi il ricordo vecchio quasi 10 mesi, di una creatura magra a testa rasa, che si dimenava ancor priva di coscienza nel letto dell’Ospedale al-Ahli; era stata operata al cervello una ventina di giorni prima, con prontezza e bravura, per estrarre la pallottola e decomprimere il cervello gonfio (la prima diagnosi al pronto soccorso era stata di ‘morte cerebrale”). Avevo sempre sperato che si riprendesse, ho esperienza di traumi cranici e so che i ragazzini fanno grandi recuperi, ma nel salottino nel quale intanto venivano imbanditi enormi piatti di frutta, mentre Ghazala tardava a comparire, la mia paura per lei cresceva. Finalmente comparve una irriconoscibile fanciulla bruna, bella e ben messa in un vestitino a pantaloni verde chiaro, mi parve un po’ incerta ancora nel movimento e nel linguaggio. Ma era tutta timidezza. Apprendemmo che era già stata precocemente rioperata per riposizionare in testa il pezzo di scatola cranica saggiamente allontanato per alleviare la pressione sul cervello gonfio. Mi mostrarono la pallottola rotonda metallica, ricoperta di una sostanza molliccia, il residuo della plastica dopo l’impatto ad alta velocità col cranio. Il lembo osseo era stato conservato e riusato – era la prima volta che lo facevano in quell’ospedale. Poi la ragazza era stata riabilitata localmente e in Iraq, dove appresi esistere un centro di recupero dì alto livello (in effetti la riabilitazione richiede un minimo di tecnologia, e molta capacità personale dei curanti, e può non essere stata influenzata dall’embargo). Dopo, era tornata a scuola, superando l’esame dell’ottavo livello. Mentre scattavo fotografie e discorrevo con i parenti, un padre (agricoltore), bell’uomo fiero, una madre dal volto precocemente segnato, zie o cugine giovani e sorridenti, lo zio singolarmente giovane, innumerevoli ragazzini, inclusa purtroppo una cuginetta resa cieca da un trauma, muta e triste, Ghazala si sciolse e cominciò a sorridere. Ha una sorella e quattro fratelli. Parlava un inglese notevolmente corretto; raccontò le circostanze del suo ferimento –uscita di scuola in mezzo ad alcuni compagni stava avviandosi a casa. Non nascose il suo sentimento: “loro ci odiano e noi odiamo loro”. Vuoi fare prediche a una che hanno quasi ucciso a 14 anni? Ma Ghazala non è una dura; non ha ancora deciso che cosa fare da grande– ‘forse l’infermiera o il medico per aiutare gli altri come hanno aiutato me” e poi quando cerco di farle dire se ha un desiderio, di un regalo che possa farle per le feste , dopo qualche esitazione, dice dì far io la scelta, ma poi, a bassa voce, “un regalo mi piacerebbe molto, un pezzetto dì pace”. Oh Ghazala quanto vorrei potertelo fare, questo regalo. Qualche altra foto, ora che il sorriso la rendeva luminosa – sembrava contenta di sé – e poi dovemmo congedarci, deludendo la famiglia che ci voleva a pranzo. Solo vedemmo il terzo ragazzo colpito da disgrazia in questo gruppo familiare, un tredicenne con gravi postumi fisici e psichici di un incidente d’auto. Nell’andare, decidemmo con Jamal che qualcosa andava fatto per i due più sventurati cugini di Ghazala, e ne sta nascendo un progetto di sostegno ad attività riabilitative, specialmente per ciechi – ma anche per altri gravi casi che la struttura sanitaria palestinese, sovraccaricata dai feriti dell’intifada, non regge. Una base c‘e’ già; la “Hebron branch” della “Palestine DisablesGeneral Union” è molto attiva; incontrammo alcuni membri del direttivo, tra cui il presidente, non vedente, Ibrahim, nell’edificio di nuova costruzione donato dall’TJNDP con altri contributi locali, posto in una vasta area della zona palestinese autonoma tutta dedicata a funzioni didattiche e affini. Nell’edificio si stava svolgendo un campo di ragazzi, insieme disabili e normali, della durata di 15 giorni per ogni turno. Già in passato 180 ragazzi hanno frequentato questi campi, che sono stati un successo sia per aiutare i disabili, sia per lenire le infinite cause di disagio del quale soffrono ora i ragazzi palestinesi tra occupazione, povertà diffusa, paure di attacchi, scolarità irregolare, spettacolo continuo di morte e violenza. Di questa struttura non ancora completata, vedemmo un inizio di biblioteca, una sala con alcuni computer, un salone per giochi sportivi, una sala per disegni e altri giochi didattici, un vasto spazio all’aperto, con un embrione di giardino. L’Associazione dovrebbe esser un buon riferimento per un programma di supporto ai non vedenti con le nuove tecnologie disponibili.
Nell’agosto 2001, mentre Mimma scriveva queste annotazioni, i volontari di “Gazzella” visitavano 120 famiglie di bambini feriti adottati nella Striscia di Gaza da questa associazione (vedi il rapporto in http://www.gazzella-onlus.com/a013.html). In meno di un anno dall’inizio del progetto il numero dei bambini assistiti era quasi raddoppiato: dai 60 in aprile ai 110 in agosto.
Nell’aprile 2002, mentre gli altri volontari di Gazzella riuscivano a entrare nella Striscia di Gaza ormai totalmente sotto l’assedio delle truppe israeliane, Mimma rimaneva bloccata a Gerusalemme (vedi il rapporto in http://www.gazzella-onlus.com/a021.html):
La mia ultima visita a Gerusalemme, forse la quindicesima o giù di li’, è stata anche la più angosciosa. La speranza era di vedere la nostra Gazzella e la sua famiglia nel villaggio dove vivono vicino a Hebron, di parlare con gli interessati locali di un possibile progetto di supporto informatico per i non vedenti, certo da rinviare nella realizzazione a tempi migliori, ma che intanto era possibile preparare, infine di fare un’altra visita a Gaza e a Ramallah, forse a Gerico. Partita gli ultimi di marzo speravo che almeno una parte del programma potesse realizzarsi.
Nel luglio del 2002, i bambini feriti assistiti e adottati erano 331 (vedi il rapporto in http://www.gazzella-onlus.com/a025.html). Le crescenti attività di Gazzella tendenti ad alleviare le sofferenze delle vittime della ferocia sionista non potevano passare inosservate e ben presto il governo israeliano ha cominciato a porre ostacoli a chi tenta di salvare al vita ai bambini destinati, nei disegni di quel governo, all’annientamento. Nel dicembre 2002, dei volontari di Gazzella solo Agnese riusciva a entrare a Gaza, mentre altri due volontari venivano bloccati all’aeroporto ed espulsi come persone non grate. Nonostante i numerosi ostacoli che venivano frapposti, il sostegno di Gazzella raggiungeva 510 bambini feriti visitati nella Striscia di Gaza nel luglio 2003 (vedi il rapporto di Giovanna e Luisa in http://www.gazzella-onlus.com/a029.html). Nonostante che, a partire dal dicembre 2003 e per circa due anni, sia stato impedito ai volontari di “Gazzella” di raggiungere la Striscia di Gaza, l’assistenza ai bambini feriti è proseguita. La rete di solidarietà che nel frattempo si è strutturata, per esigenze di totale trasparenza e legalità, in un’associazione ONLUS, ha esteso le attività che oggi coprono nel campo della cura dei bambini feriti da armi da guerra, centri di riabilitazione e sostegno ad altre strutture sanitarie, sia nella Striscia di Gaza sia in Cisgiordania.
Fino alla fine, come sempre attenta e lucida, Marina Rossanda aveva seguito l’attività dell’associazione di cui è stata presidente. Anche sul letto di morte si preoccupava della sorte di “Gazzella”. Tutti noi che abbiamo a cuore la sorte dei “dannati della terra” la ricordiamo con affetto e portiamo avanti con lo stesso rigore di sempre l’impegno che Marina non ha mai abbandonato. L’articolo scritto da Marina dopo il viaggio in Palestina con Marisa Musu nel novembre 2000, spiega al meglio la nascita e l’impegno successivo con cui ancora opera l’associazione “Gazzella”:
Sono tornata in Palestina alla metà di novembre, dopo cinque anni di assenza. Nonostante la nostalgia, salute e impegni mi trattenevano a Roma, e comunque, dagli accordi di Oslo in poi, non ero più motivata. Pensavo: i palestinesi hanno fatto la loro scelta, e se anche questa non mi convince, hanno diritto e magari buone ragioni per averla fatta, auguri di cuore, spero di sbagliarmi. Purtroppo non mi sbagliavo o almeno non interamente.
Non mi sbagliavo nel senso che il processo di pace si è trascinato per sette anni tra accuse e rinvii, e nel frattempo i governi israeliani hanno lavorato a creare situazioni di fatto compiuto, in barba agli accordi, consolidando e ampliando l’occupazione, mentre gli amici occidentali si beavano delle parole di pace. Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gaza (definite aree C negli accordi) si sono ampliati e moltiplicati[1], si è estesa una rete stradale diretta a collegarli con Israele e fra di loro, mentre i percorsi tra le città passate al controllo palestinese ( aree A ) erano sempre più disagiati. Nelle aree intermedie (aree B) il controllo era di fatto di Israele. Si è così progressivamente estesa la linea di confine e d’attrito tra le due popolazioni, solidamente tenuta dall’esercito israeliano e dai coloni armati, di forza preponderante rispetto alla polizia palestinese. Gli attriti sanguinosi in realtà non sono mai cessati, e, benché i giornali israeliani siano pieni di lagnanze sulla insicurezza dei propri cittadini, gli attacchi sono stati, in grande maggioranza e nel silenzio della stampa europea, condotti da coloni o soldati ai danni di palestinesi nelle aree di attrito. Dove, come a Hebron, era stata introdotta una ‘forza d’interposizione’ questa non aveva alcun potere effettivo. Secondo il Children defence international (Cdi) solo a Hebron e solo nel 1998 (due anni prima della nuova sollevazione) sono state più di 100 le incursioni di coloni e soldati, alcune con esiti tragici. Inoltre le questioni di fondo dell’acqua e dello statuto di Gerusalemme, per citare i problemi più grossi sul tappeto, restavano irrisolte.
Mi sbagliavo invece sottovalutando gli effetti politici del riconoscimento formale di un popolo negato per mezzo secolo dal progetto sionista, del suo controllo su alcune città, dell’occasione non sprecata di porre basi – benché fragili – per la nascita di uno Stato palestinese. Ci sono ministeri che hanno lavorato bene, specie nei campi praticamente accessibili, come educazione, affari sociali e sanità; si sono moltiplicati i centri di studio delle donne, le istituzioni per la difesa dei diritti; studiosi si cimentano nello studio di progetti, i legami con le organizzazioni non governative sono diventati permanenti; se non si è realizzato il massiccio piano di finanziamenti lasciato intravedere all’inizio dagli organismi finanziari internazionali, e se errori seri ed episodi di corruzione ci sono stati da parte palestinese, tuttavia alcune infrastrutture sono state realizzate (l’aeroporto di Gaza, edifici pubblici, sezioni ospedaliere moderne, nuove aree universitarie). Uffici dell’Organizzazione mondiale della sanità, boicottati o controllati prima da Israele, si sono consolidati, il CDI ha la sua sezione palestinese, e, col rapporto consegnato alla inviata dell’ONU per i diritti umani Mary Robinson[2] sulle uccisioni e ferite di minorenni, ha provocato la sua protesta indignata e ‘shockata’. Professionisti, docenti, esponenti politici palestinesi hanno intensificato i loro rapporti con i corrispondenti europei, e dei paesi arabi in particolare, con regolare presenza in incontri internazionali. Resta la grave sofferenza nell’economia e nel lavoro, campi nei quali l’occupazione israeliana ha creato vincoli così stretti da impedire azioni incisive; quindi disoccupazione, povertà e disuguaglianze sociali pesano su umori e speranze. Ma qualche cosa si muoveva.
È probabile che la destra israeliana, dotata di un cospicuo potere di ricatto anche sui governi laburisti, abbia stimolato il “partito dei coloni” e altri gruppi oltranzisti a intensificare, man mano che si rendeva visibile la pur faticosa crescita dell’autonomia palestinese, le provocazioni, culminate nella famosa visita di Ariel Sharon alla spianata delle moschee. L’intifada di al-Aqsa, esplosa dopo la sanguinosa repressione della protesta palestinese, potrebbe essere stata provocata e ricercata dalla destra come pretesto per mettere in atto reazioni violente, trascinare i palestinesi esasperati a scegliere essi stessi la via delle armi, nonostante la gigantesca sproporzione di forze, e tentare così di giustificare un’azione militare diretta all’annessione dei territori; sarebbe così morta sul nascere la stessa autonomia palestinese. Mentre ero laggiù questa ipotesi non sembrava fantasiosa. Tuttavia le proteste arabe – forse per la potenza simbolica di Gerusalemme tra i loro popoli irrequieti, forse per timore dell’ulteriore crescita di egemonia israeliana nell’area – furono più unitarie e inquietanti del previsto per Israele. Il progetto sembrava rallentato alla mia partenza, mentre arrivavano numerosi in Palestina i testimoni della stampa estera e di associazioni europee, e la stessa economia israeliana accusava qualche colpo.
Le contraddizioni insite in questa situazione erano iscritte nella nuova immagine che ho registrato della Palestina nello scorso novembre. Strade in parte nuove nel percorso tra l’aeroporto di Tel Aviv e Gerusalemme. Gli insediamenti intorno alla città contesa avevano divorato vaste parti della incantevole campagna. Se i ricordi del fascino della vecchia città trovavano consolazione nei quartieri vicini alla Porta di Damasco, via Salah-ed-Din e fino alla salita di Sheikh-el-Jarrah, poco cambiati, bastava avviarsi a nord verso Ramallah, teoricamente chiusa dall’assedio, per entrare in un paesaggio mutato. La superstrada proveniente dagli insediamenti del Nord tagliava la zona delle ville dei consolati, rasentando una nuova area sportiva, un parco intitolato alla “Riunificazione di Gerusalemme” e nuovi quartieri. Più a nord ancora, cantieri sempre più estesi accanto ai sobborghi e campi di rifugiati palestinesi, fino ad aree di terra rossa sconvolta dalle ruspe e sassosa, senza quasi più ulivi, con vista su insediamenti ampliati, al di qua di una campagna ormai lontana, evocata dalla memoria.
Per sentieri scoscesi si arrivava lentamente a Ramallah, aggirando il posto di blocco sulla strada asfaltata, sobbalzando nei pulmini-service carichi di viaggiatori più rassegnati che tranquilli. Ma a Ramallah si trovava una città palestinese; pur sapendo che era attaccabile – e attaccata la sera e la notte – da terra e dall’aria, non aveva l’aspetto della città occupata. Piena di bandiere e targhe palestinesi su edifici e veicoli pubblici, con pochi e non invadenti poliziotti palestinesi, caotica ma piena di gente pronta a indicare la strada, un monumento bruttino con quattro leoni donati dalle quattro famiglie di notabili palestinesi, una periferia in via di espansione con borgate residenziali gradevoli alte sulle colline un po’ spelacchiate. Bel panorama, peccato che qui arrivassero ogni tanto i colpi sparati da coloni o soldati da 1 o 2 km di distanza.
A Hebron era peggio; vi si arrivava per sentieri da capre perché la strada normale era ‘ msakkara ‘, chiusa dal posto di blocco, gridavano le poche donne circolanti. Ci siamo arrivati rinunciando a Betlemme e Beit Jala dove nemmeno la macchina delle Nazioni Unite era ammessa e l’aggiramento impraticabile. A Betlemme le feste per Natale sono state cancellate dalle autorità cristiane, salvo la stretta liturgia religiosa. Dentro Hebron la frontiera tra le zone H1 e H2, previste dagli accordi che hanno accettato di mantenere l’insediamento ebraico nella città vecchia, si presentava nuda e minacciosa, una breve strada in terra di nessuno era percorsa da scolaretti spaventati perfino dalla nostra presenza. A un passo, nel cuneo di zona israeliana, al mattino era il deserto, per il pomeriggio erano attesi i soldati mandati a difendere pochi coloni: andavano anche sul tetto di una casetta abitata da una tenace donna palestinese, i cui figli cresciuti erano ben sistemati altrove. Sul terrazzo, i soldati avevano disposto nidi di sacchetti di sabbia per meglio sparare sui dintorni. Ma sulle case palestinesi arrivavano la sera anche colpi di mezzi anticarro, perforando tubi di ferro, staccando cornicioni, rompendo vetri: una sera hanno spaccato la testa a un padrone di casa andato incautamente a rispondere al telefono.
Nella zona della città vecchia dove vivono armatissimi 400 coloni, erano sotto rigido coprifuoco fin dall’inizio della nuova intifada 20.000 (chi dice 40.000) Palestinesi senza più accesso a scuole o ambulatori. Un altoparlante stava annunciando il permesso di andare per una o due ore a un punto medico di emergenza aperto dall’UNRWA in una scuola chiusa. I visi dei ragazzi, delle donne e degli anziani in coda parlavano di miseria e tensione. Non lontano era un ambulatorio regolare UNRWA, con residui di gas lacrimogeno, donne incinte che se ne riparavano in fretta, per timore di abortire, un neonato dal respiro ancora disturbato (vari neonati sono ammalati o morti per questo). Nell’ospedale al-Ahli, moderno, alla ricezione una giovane con velo e computer sotto il ritratto di Arafat e manifesti dell’ intifada ; dentro, vari feriti, tra cui una ragazzina in risveglio da un coma grave, con il cranio fratturato da un proiettile “di gomma”, in realtà d’acciaio rivestito di gomma, di quelli che usati con malizia hanno ucciso o accecato vari bambini. La malizia non stava nella cattiveria di singoli soldati, ma negli ordini ricevuti, documentati da una giornalista israeliana di “Haaretz”[3], Amira Hass, nell’intervista a un tiratore scelto dell’esercito. Gli ordini erano di sparare anche ai ragazzi, purché di almeno 12 anni e con l’aria pericolosa. L’analisi delle ferite e le circostanze delle uccisioni descritte da varie fonti hanno confermato la volontà di sparare per uccidere. Il Cdi ha pubblicato sul suo sito internet[4] una lista dettagliata di 95 minori uccisi tra il 28 settembre e il 30 novembre 2000 (30 sotto i 15 anni). Ci sono liste di feriti sotto i 14 anni, quasi 500 a Gaza, più di 200 in Cisgiordania.
Nablus e tutto il Nord della Cisgiordania erano inaccessibili per sparatorie anche diurne, che hanno crivellato tra l’altro una macchina dell’Onu. A Gaza fu ammessa solo la mia compagna di viaggio in quanto giornalista, e anche lei solo nella metà palestinese, mentre quella degli insediamenti controllata da coloni e soldati era zona di guerra. Così anche il nuovo ospedale donato dall’UNRWA a Khan Yunis era al momento off limits. I rifornimenti di alimenti, farmaci, carburanti erano bloccati alla frontiera con l’Egitto, tenuta sotto tiro dai cecchini israeliani.
A Gaza volavano sassi, invettive e pianti per gli shahid (i martiri), qualche sparo, mentre procedeva una vita quotidiana testarda, come in tutti i territori occupati, impegnati in una sollevazione ‘per l’indipendenza’, sfidati a una guerra che non potrebbero vincere e i più saggi non vogliono, per ora senza guerra e senza cedimenti.
Domani chissà.
note:
1 Nel sito dell’organizzazione pacifista israelo-palestinese Gush Shalom (http://www.gush-shalom.org/) si può leggere uno studio approfondito sulla politica delle demolizioni di edifici abitati dai palestinesi praticata dallo Stato di Israele: Demolition Peace: Isarel’s Policy of MassDemolition of Palestinian Houses in the West Bank.
2 Al sito della Commission of Human Rights delle Nazioni Unite (http://www.unhchr.ch/) si può leggere il rapporto Question of the Violation of Human Rights in the occupied Arabs Territories, including Palestine.
3 Il periodico della sinistra israeliana si può trovare al sito http:// www.haaretzdaily.com/htlms/1_1.htm
4 http://www.childrensdefense.org/