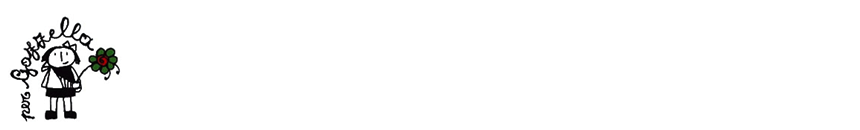Relazione del viaggio a Gaza – ottobre 2006
RESOCONTO DEL VIAGGIO NELLA STRISCIA DI GAZA E IN CISGIORDANIA
12-25 ottobre 2006
Cari amici di Gazzella,
sono passati solo tre mesi dal mio precedente viaggio ed eccomi di nuovo nella Striscia di Gaza. Solo chi, come me, lo ha vissuto personalmente riesce a comprendere appieno i sentimenti contrastanti e laceranti che ti suscita la Palestina e il suo popolo: quando non sei lì, con loro, fremi per volerci essere, ma una volta arrivata in questa terra gli eccidi quotidiani, la miseria e la disperazione condivisi, ti fanno sperare – e con vergogna – di esser fuori al più presto da tutto questo orrore. Sono arrivata a Gaza il giorno 12 ottobre, dopo i ‘soliti’ controlli (raggi non meglio identificati, perquisizioni personali) al posto di blocco israeliano di Erez.E’ ancora il mese sacro di Ramadan. Al posto di controllo Palestinese osservo i soldati che stanno pregando, cosi come i due tassisti che aspettano i pochissimi volontari internazionali che ottengono dagli israeliani occupanti il permesso di entrare a Gaza. Per una mezz’ora attendo che finiscano le loro preghiere, infine con una macchina mi dirigo verso Gaza città.La distruzione e’ ovunque, le strade sono vuote. Nella sede del Medical Relief mi danno il benvenuto l’amico Abu Khusa ed Ilham, la collaboratrice di Gazzella a Gaza. Mi abbracciano, sono felici di rivedermi. Mi raccontano una quotidianità che fa spavento: attacchi israeliani continui, energia elettrica a singhiozzo (viene erogata sei ore al giorno, ma suddivisa in tre fasi), fra la gente c’è disperazione e sfinimento, mancano i generi di prima necessità, il prezzo del pane e della farina è alle stelle, letteralmente le madri non hanno cibo per sfamare i propri figli. A Gaza è ancora estate e così quella stessa sera decidiamo, Ilham ed io, di andare a fare una passeggiata sul lungomare. Chiacchieriamo, ci scambiamo notizie su amici comuni, camminiamo lentamente godendoci il vento fresco che ci fa dimenticare l’afa del giorno. Poi ci sediamo all’aperto a bere un succo di frutta. Sembra una serata piacevole, come probabilmente – io, voi – abbiamo vissuta tante volte. Sembra, ma non è così. All’improvviso sentiamo una fortissima deflagrazione, vediamo fumo in lontananza, e subito dopo il suono di sirene di ambulanze. La gente nella strada inizia a correre ed urlare. Chiediamo notizie e un ragazzo ci dice concitato che gli israeliani hanno bombardato una casa poco distante: per ora si contano 2 morti e 20 feriti……
Nei cinque giorni della mia permanenza a Gaza gli ‘omicidi mirati’ faranno 25 morti, tra civili e resistenti. Le mie giornate saranno scandite da bombardamenti, funerali, pianti, colpi di fucile, preghiere….
Su tutto aleggia lo spettro di una possibile guerra civile fra palestinesi (che farebbe molto piacere agli occupanti): la nuova polizia istituita dal Presidente Abu Mazen, denominata Palestinian Military Police (P.M.P), controlla la Polizia Palestinese agli ordini di Hamas. Durante la mia permanenza a Gaza si sono verificati scontri a fuoco fra le due parti, ma per fortuna ancora contenuti, nessun palestinese vuole una mattanza tra fratelli. Però in molti accusano Abu Mazen di non riuscire (volere?) a tenere insieme il suo popolo.
Con Ilham ho visitato l’ospedale Nasser di Khan Yunis, l’ospedale Abu Yusef di Rafah e l’ospedale Kamal Edwal di Jabaliya: bambini e adolescenti nei loro letti avvolti da garze e tubicini, ci guardano con occhi smarriti e spenti, restano muti, neanche un sorriso….. da lontano osserviamo sgomente quelli incoscienti che giacciono in sale di rianimazione sempre più precarie. Ogni volta e sempre ricaccio indietro le lacrime, mi faccio forza, decido di parlare personalmente con i medici, voglio verificare di nuovo e testimoniare la disastrosa situazione sanitaria degli ospedali, vedere ‘cosa’ viene estratto dai corpi dei feriti, e come si presentano queste ferite. Sia dal ‘materiale’ estratto che mi mostrano i medici dei vari ospedali, che dalla visita che personalmente faccio ai sette nuovi bambini presi in adozione, posso appurare che i loro corpi presentano ampie ferite e alcune parti del corpo sono bruciate internamente. Un medico dell’ospedale di Khan Yunis mi racconta di due “strani” casi: alcune persone ricoverate presentavano sul corpo solo piccole bruciature, che apparentemente non hanno destato alcuna preoccupazione: per i medici i pazienti non correvano pericolo. Ebbene, questi feriti, nell’arco di tre giorni sono deceduti. L’autopsia ha rilevato che i loro organi interni erano consumati, probabilmente per effetto di armi non convenzionali. D’altra parte è stato denunciato – anche in Italia – già dal luglio scorso l’uso da parte degli israeliani, sia in Libano che nella Striscia di Gaza, di armi probabilmente batteriologiche o chimiche o al fosforo…… ma forti del silenzio e della complicità internazionali, gli israeliani continuano nei loro mortiferi esperimenti.
I medici palestinesi, però, pur dovendo operare ogni giorno con scarsità di medicinali adeguati (mancano addirittura garze e guanti sterili monouso), pur dovendo affrontare turni di lavoro intollerabili, e infine costretti a prestare la loro opera praticamente senza salario a causa della mancanza di fondi dovuta all’embargo economico, nonostante tutto questo, vogliono denunciare e far conoscere cosa si sta consumando in questi mesi nella Striscia di Gaza. All’ospedale di Jabaliya ho avuto dai chirurghi una richiesta “particolare”: la mia macchina fotografica in prestito, per permettere loro di scattare immagini in sala operatoria e testimoniare delle ferite che si trovano a curare.
Le mie giornate a Gaza sono trascorse condividendo con i miei amici palestinesi il Ramadan, ho visitato famiglie già conosciute e ne ho incontrate di nuove, accolta sempre con una gentilezza e un’ ospitalità da noi sempre più rara e che ogni volta mi stupisce; mi sono seduta alla loro tavola nel pomeriggio, in attesa che il sole calasse, per iniziare poi a condividere un pasto spesso frugale, ma mai misero e sempre profondamente dignitoso.
Lasciata la Strisciadi Gaza, al mio rientro a Gerusalemme, ho incontrato Ugo, il tesoriere di Gazzella, con il quale avevamo in precedenza organizzato il proseguimento del viaggio verso la Cisgiordania, a Nablus ed Hebron.
Al nostro arrivo al posto di blocco di Awara a Nablus, ci siamo ritrovati assieme a circa trecento palestinesi in attesa di poter entrare nella città nella quale era in corso una ‘operazione militare’; le vie di accesso e di uscita per e da Nablus erano tutte chiuse. Siamo rimasti per più di un’ora in attesa, con i fucili dei soldati israeliani puntati contro, insieme a donne, uomini, vecchi e bambini, nell’afa e nella polvere, sotto un sole cocente nonostante l’ottobre inoltrato. Quando finalmente i soldati hanno riaperto il posto di blocco, Ugo ed io invece di metterci in fila per passare a piedi il controllo, siamo riusciti a trovare un passaggio su di un mezzo che prestava servizio sanitario e per fortuna questa opportunità ha abbreviato i tempi: l’attesa ad Awara e’ stata di “sole” due ore….
A Nablus ci attendevano i medici e i volontari del Medical Relief per accompagnarci a visitare le famiglie dei bambini di nuova adozione in Cisgiordania: solo a Nablus abbiamo 18 nuove adozioni. I bambini vivono tra la città vecchia ed il campo profughi di Balata che conta 20.000 abitanti. A Balata abbiamo riscontrato situazioni di incredibile povertà, vera e propria miseria. In questo campo sono tornata a visitare un bambino in adozione, che avevo già incontrato lo scorso mese di luglio per la prima volta; gli ho portato un piccolo regalo che la famiglia italiana mi aveva consegnato: la sua felicità mi ha turbato e commosso. Mi viene da pensare che certamente è fondamentale offrire un sostegno economico a queste famiglie, ma se a ciò si unisce il segno di una presenza più forte, come ritornare in visita con un dono, (sempre che gli israeliani non te lo distruggano durante uno dei tanti controlli) o anche solo una fotografia della famiglia adottante, questo è certamente un messaggio di solidarietà e vicinanza importante.
Il nostro rientro a Gerusalemme, il giorno successivo, non e’ stato semplice. Al posto di blocco di Awara abbiamo sostato e perso un’ora, un tempo tuttavia breve rispetto a quello speso dai palestinesi che passano il controllo a piedi e che quindi si trovano costretti in centinaia in quella situazione. Ugo ed io abbiamo potuto permetterci di pagare un mezzo di trasporto e questo ci ha “accorciato” i tempi. Il direttore finanziario del Medical Relief ci è venuto a prendere a Ramallah; in caso contrario avremmo dovuto cambiare taxi collettivo a Piazza al-Manara per raggiungere il posto di blocco di Qalandiya, quindi passare il controllo e riprendere un altro taxi collettivo per Gerusalemme. Come al solito i 40 km che dividono Gerusalemme da Nablus vengono percorsi in 4 ore.
Durante i nostri ultimi giorni di permanenza, Ugo ed io, abbiamo visitato i bambini di Hebron. Tutti i bambini che abbiamo incontrato nella Cisgiordania presentano ferite invalidanti che richiedono più interventi chirurgici, come quello di cui necessita una bambina di Hebron che dovrà sottoporsi al quarto intervento poiché il proiettile esplosivo che l’ha colpita alla caviglia e alla gamba le ha letteralmente spappolato i tendini e nervi.
Voglio concludere questo mio racconto con un episodio di gioia e di speranza. Agli inizi degli anni ’90, sedici anni fa, Imad, un bambino di Hebron allora tredicenne, aveva trascorso assieme ad un gruppo di bambini palestinesi una breve vacanza in Italia – solo una settimana di divertimenti in un paese per loro lontano e sconosciuto. Imad era stato ospitato da una famiglia di mia conoscenza. Da allora la famiglia ha conservato gelosamente una foto polaroid che li ritraeva assieme al bambino, e su uin pezzo di carta il suo nome scritto in arabo. Sapendo che presto mi sarei recata in Cisgiordania, mi hanno chiesto se era possibile rintracciarlo, e mi hanno consegnato sia la foto sgualcita e scolorita, sia il biglietto con il nome. Ad Hebron ho cercato traccia del ‘bambino’, ero disillusa, in una terra di lutti e dispersioni. Invece sono stata fortunata e lo scorso 23 ottobre ho incontrato Imad, oramai 29enne. Fatico a descrivere le emozioni che entrambi abbiamo provato. Imad, e con lui suo padre, mi chiedevano in continuazione come fosse possibile che dopo sedici anni una famiglia avesse ancora una memoria così forte di una visita tanto breve di un ragazzino con il quale negli anni successivi non avevano più avuto contatti. Avrei dovuto spiegare ad Imad che per Ave e Carlo il mantenere vivo in loro il ricordo di lui per tutto questo tempo, aveva significato in qualche modo far proprio il dramma di un popolo che vive sotto occupazione militare, che vede i suoi figli nascere e crescere in un campo profughi, un popolo che affronta vessazioni e violenze con coraggio, un popolo che merita rispetto. Ma forse questo Imad già lo sa.
Giuditta